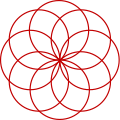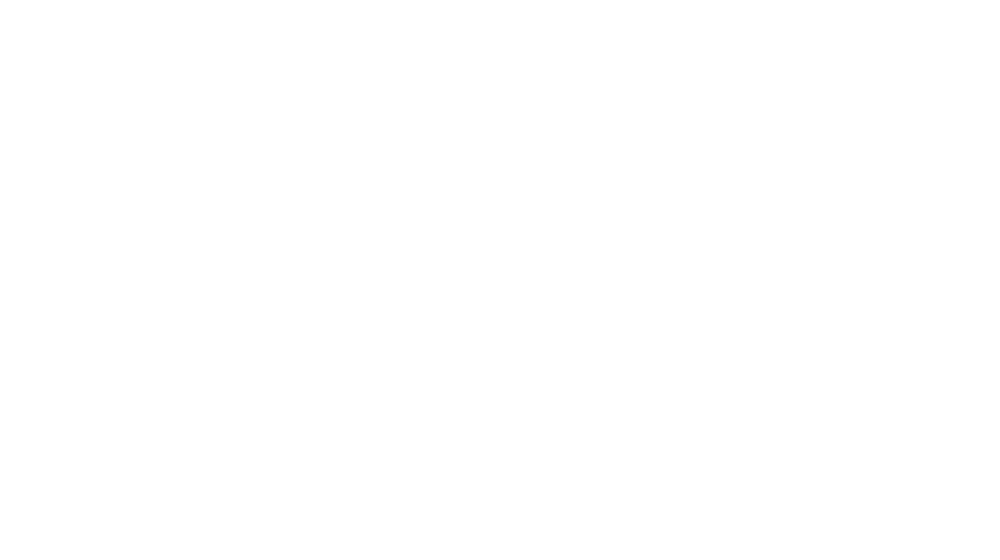Fotografia di Massimiliano Ferrante
Fallone Editore 2024
collana Il fiore del deserto
Prefazione di Isabella Bignozzi
Dalla prefazione: “Un’oscura devozione all’inconoscibile”
Da una “latenza logora” Antonio Tammaro eleva il suo canto in Via da questa arsura (Fallone Editore 2024), opera copiosa e di pregio, che delinea una condizione umana di lacerata ricerca: in cui la creatura conosce il bilico, vive perplessa e dilazionata, mentre sfibra di precarietà. È l’arsura dell’eccesso, la veemenza della carestia che il poeta espone in questo lavoro crudo e proteiforme, nudo e barocco, la cui essenzialità si staglia via via durante la lettura come un rigore vertebrale sottilissimo: un’affranta, scabra serenata alla vita, una ballata d’arcaica magia. Come la terra molisana patria del poeta, il cui linguaggio remoto, litanico è miscelato con auliche sovranità e luminescenti scorie: in un dialogo interiore ininterrotto, contaminato da lemmi forestieri; fino a dare senso di un fluire caotico, madornale, intriso di un arduo splendore Simbolo di una dolente totalità, che incede logorando la percezione, stremando l’intenzione; inducendo, nel buio perfetto della resa, un’oscura devozione all’inconoscibile […].
“Servirebbe una visione, azzardava già il poeta in apertura, “un paesaggio inatteso / che lasci alle cose frante / la cura, una rosa”: quel “raggio della beatitudine – diceva Hugo von Hofmannsthal – colore del miele, sovraterreno, cui cede ogni tenebra, davanti al quale ogni orrore si scioglie”1 .
E così Tammaro, in chiusura, lenisce parola e teoria, dismette l’opinione, e si attenua in incanto; “realtà che non parla, selciato che si cammina scalzi, finestre spalancate, vetri rotti tra le rovine di una casa diruta e languore che si spoglia del tetto, delle mura, degli orpelli, è bellezza che non striscia e non dimora nella vanagloria della scrittura”.
Ma a questo silenzio postumo, di strumento posato, alla contemplazione muta dello splendore che irradia finanche dal dissesto, si arriva dopo aver percorso le labirintiche, faticosissime vie neurali del ragionamento e del linguaggio: e allorquando l’unico mezzo di indagine e comunicazione che abbiamo, la parola, mostra la sua disfatta, un’estasi taciturna pone il vivente nel baricentro di ogni cosa, dove tutto riposa e tace: nell’umiltà purissima dell’ascolto, che è pazienza e perdono, la via per la custodia del cuore, e per ogni nostra intima integrità.

*
Da: Via da questa arsura, Fallone Editore 2024
A detrimento di questo refolo
su per le coste del paese
tra le spine e le pareti di cicute
dalle fioriture bianche a spume
con la faccia al muro ad ascoltare
le fontane aperte per le scale
rogge precipitose giù a calare
e gli uccelli che non ce la fanno
a non controcantare illusi
o forse noi poveri
rintronati dal giorno che tira.
Quest’anno senza inverno
come dei cristi derubati
mendichi di neve
tritiamo il guscio alle parole.
*
Alla vista già sfinita dei campi,
in ogni posto, ci attende il tracciamento
per il viaggio che riprende.
E, nel corso, ritorna il desiderio.
Con le sue voci lo trascina il giorno
che s’oscura della luce di settembre
al gonfiore crudele del cielo
tanto azzurro da strappare il fiato,
nella speranza che arrivi presto
la pioggia, un temporale, una tempesta
a dissipare l’ansia di questa stagione muta:
acqua rovinosa, cupa, bella,
che s’appigli, furente, agli alberi, alle case,
al tronco nudo dell’anima sospesa.
*
C’è un frinire che allenta
la notte si va facendo muta
il nostro passo cede
al lungo incupirsi delle cose
troppe già le consunzioni
persino al mare si trascura
l’ultimo sguardo di riflesso
tra le meridie crespose
breviari di note sulle mura
lasciano trame a scaglie
come di pesci senza coda
maestri di prestigiazione
cacciatori di serpenti
cosa ci rimane ancora
un sussulto che spaura
una parola sola.

*
È una linea di mezzo, un modo di stare,
resistere con la durezza del corpo
e la nostra anima dolente.
Dopo anni di vita feroce,
di tempo perso dietro gli affanni,
avvertire quella spossatezza
che ci prende le gambe
e ci tiene ancorati alla terra.
Un bacio, un viso, gli alberi spogli
che attraggono il sole, un fiato,
un tuffo nei colori accecati dall’aria
di questa stagione.
*
Fammә scappà com’a quella vòta
perdutə ent’a ru vòschə addo sa sèntə
ru sciumə che allucəra e s’annasconnə.
Làssəmə a lə pretə, ‘mmez’a lə fronnə,
a respirà laddorə də lavanna
Semə ri figlia də n’infanzia bella,
crisciutə spiànnə còscə a uagliòlə
che jucavənə a palla prigioniera,
e pazziànnə se facettə scurə.
–
Fammi fuggire come quella volta
perduto nel bosco dove si sente
il fume che trasporta e si nasconde.
Lasciami alle pietre, tra le fronde,
a respirare l’odore di lavanda.
Siamo i figli d’un’infanzia bella,
cresciuti spiando cosce a ragazze
che giocavano a palla prigioniera,
e giocando si fece sera.
*
L’odore lo senti di maggio,
di erba dentro ti entra
di malva, di acacia succosa,
di orti impregnati dal vento,
di capelli, di rovi, di rosa.
Diventa così cupa la terra
che nel profondo, il seno ti trema
e non ti basta il profumo di maggio
vorresti chissà cosa vorresti.
Bruciare come il fuoco di notte e di giorno
salire in cielo per precipitare all’inferno,
andare di corsa da lui, commettere
uno sbaglio, una frenesia per un sospiro
che ti faccia impazzire per sempre,
ubriacarti di baci la bocca
e stordirti ancora di quella febbre
che lentamente ti spegne.
*
Nella tela si ritrae in silenzio
il rivolo logoro della vergogna.
Al mondo così gracili le prede,
spoglie di lamelle emergono, supplicano.
Guardiamo l’oceano luccicare nei flutti,
carezzare la sabbia che sgorghi alla vita.
Le verità s’addensano nelle pupille dei folli
nutrendosi di fango e di radici molli
le stagioni si fanno cartilagine e unghia.
Raccontami la colpa senza memoria,
la bellezza delle cosce tese all’infinito.
Nella visione di un fiato cosmico la fine.
Fummo più di carne, più di materia,
essenza di un respiro, eterno breve,
imperfetti e nudi come le parole.
*
Padre e figli insieme in questa
età di cura
dove l’astro abbaglia sul colle
della croce.
*
… ho bisogno delle parole del mondo ma il mondo non
ha bisogno delle mie parole, altrove è la realtà che non
parla, selciato che si cammina scalzi, finestre spalancate,
vetri rotti tra le rovine di una casa diruta, è languore
che si spoglia del tetto, delle mura, degli orpelli, è bellezza
che non striscia e non dimora nella vanagloria della
scrittura.
*

Antonio Tammaro è nato a Campobasso nel 1969 e vive a Sepino, Ha pubblicato una guida cartacea sugli scavi archeologici di Saepinum dal titolo Alla scoperta della città dissepolta e diversi testi divulgativi sulla storia locale. È stato vincitore per due volte del premio letterario “Le streghe di Montecchio”, ottenendo la pubblicazione di due racconti con la casa editrice Fefè Editore. Inoltre, ha vinto diversi premi per poesia inedita, anche dialettale, e alcuni suoi testi sono presenti in antologie e riviste di poesia. Via da questa arsura è la sua Opera Prima.
- Hugo von Hofmannsthal, La scena come visione di sogno, in: L’ignoto che appare, Scritti 1891-1914, a cura di Gabriella Bemporad, Adelphi 1991 ↩︎