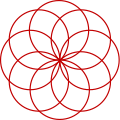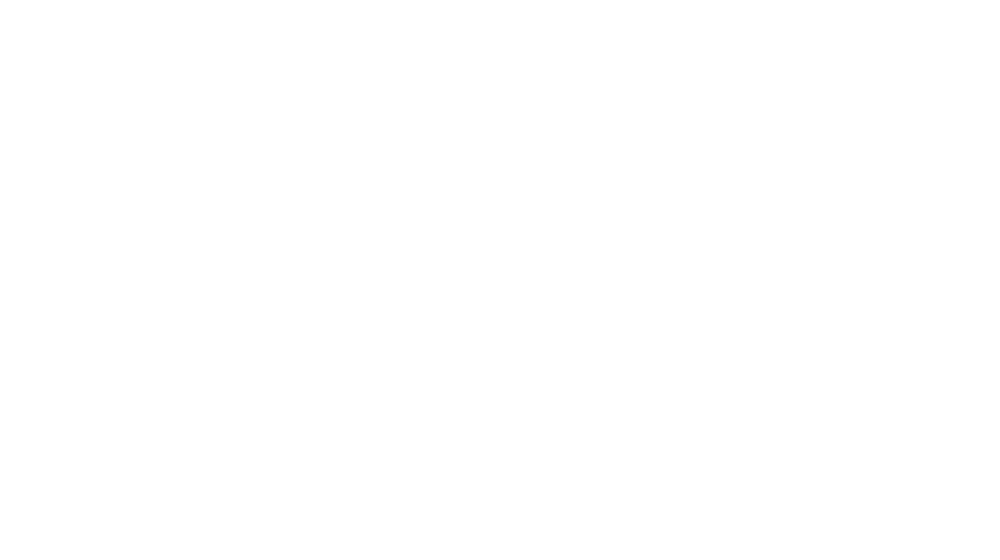#Caravaggio
la vita è breve, e io ho mal di testa
in petto non ho un cuore, ma una testa
di Caravaggio, una testa che tutto santifica
e pazienta, a cui è convenuto intorno
il mondo e siede fuori,
ché dentro vive una chiarezza
selvaggia,
pellegrinaggio di stille-gocce
rosse che sembrano ciliegie
a specchiarsi nella maglia
che divide l’esca dallo scarto,
il prezzo dal suo pregio:
‘dov’è la firma? dov’è il tuo sangue?’
gridano i parenti accatastati
nella stanza, calcolando il torto,
la sfortuna che li appiana
intorno a un morto – bisbigliano: ‘è tutto distrutto’,
ma la cardiaca testa
batte la sua fronte al petto
e tutto incensa, sibila che è
‘solo memoria’, giardino d’infinite gobbe
a cui si inciampa
sempre. poi si allontanano,
continuano la scena nel salone –
‘ancora si ha bisogno di un gigante
da ingannare?
ancora?’ – penso,
e fingendomi dentro
questo pensare, la testa chiama
a scovare dentro il viso disgraziato la persona
d’un dio fatto di specchi e d’ostacoli
corrotti, un dio che dica: «io non sono, io –
chissà quante volte – sarò stato Bacco».

*
#saluto
c’è un ombelico convocato dentro un canto
di madri e lettere bucate al centro,
buone a fare breccia in un fronte straniero
o a riformulare la trappola del tempo –
ma sulle distanze ritorna
il tuo saluto come uccello
che una volta aperto
prediceva dalle viscere un futuro
nostro o d’altri – non so più,
perché nascosto sempre dietro
un punto di stupore
che nei ricordi ritardando passa pure,
e poi come pianta-volontà rinasce
voluto solo da sé stesso; ritorna
il tuo saluto,
adesso, contenendo
in sé il suo contesto;
e ci trasvola intorno,
su questa tavola di marmo
dove c’è solo un grappolo di uva
d’avanguardia, senza semi
– e forse siamo noi,
forse dobbiamo entrarci dentro,
sminuirci così tanto da accoccolarci
nella polpa delle stagioni e dei suoi insiemi:
anatomizzarci fino al colmo, fino a diventare
tu il tuo saluto ed io il suo ricordo.

*
#verrà
abbiamo in noi ciò che davanti ai nostri
occhi il mondo cela, proteggendoci:
faccia che da nessuno specchio
sa più risalire: ‘domani
verrai, domani?’ – pensa senza dire,
con una fronte trascorsa da due decenni
appena, si rivolge al suo animale
immaginario, che vive di immobilità
esili e lontane come paradisi:
‘certo, certo che verrà!’ dice tra sé
con la testa in fondo al suo sorriso;
in fondo, ma banali
sono gli abissi, superfici
ripetute e ripetute in un giorno o una vita
che più s’usa e meno serve –
banali per me che credo
che, dall’apice sino all’appendice,
tutto sia fatto d’angelo
e l’angelo non smette mai di ridere:
il riso suo è tra noi
detto «silenzio» –
e da qui, da questo
millennio in cui si credono rocce e sono
uomini di ghiaccio, sento piangere tutti.

*
#ottomiliardiemezzo
approssimativamente siamo
otto miliardi e mezzo di segnali-di-pericolo
intorno girando
a ciò che non ha corna, artiglio, né denti –
c’è un vuoto al centro
per cui si urla sempre
‘al lupo, al lupo!’, ma il lupo è nostro figlio
e noi non abbiamo figli: persi
nell’ontologico pesarsi
del niente sul piatto del niente,
ci muoviamo nel mondo
disarmati e dubitando
del ‘perché’ non si dovrebbe esserlo –
e sappiamo pure che un sacrificio non ha più bisogno
di vittime speciali, ma d’algoritmi
o solo d’un sonno
che ci stanchi, se c’è sempre
unità in quello che ci manca, nella felicità
che radia la radice nel domani e ci traduce
l’oggi in un intero, in un bel fiore
che non toccheremo,
come sa chi solo sa quanto è lontana
la mano dal toccare.

*
ade suo visibile
fluren warten
(M. Heidegger)
vedo questo figlio di legno nel mio
prato verde-silenzioso come serpe,
penso:
chissà suo padre εὔτειχος*,
e altissime crepe, e il suo folle
peso di radici sulla terra
che pure impera dentro
la storia d’un foglio;
chissà cosa starà gemendo; se è ‘vivo’ o cosa:
del figlio mi domanderebbe, dall’alto
dell’ade suo visibile; o se, magari, questo figlio sia finito
‘a balbettare in qualche focolare di provincia’ –
‘Quercia che secoli passi,
sai che il tuo legno non è legna adatta a crocifissi –
direi – né a spaventare ladri e satanassi, ma…’;
ma questo tronco è muto,
la sua ascendenza incerta:
forse, quello che sento è solo un convoglio
d’impressioni che additano avi dentro l’uva
che spinse un uomo a non fermarsi prima
d’un abuso; forse è soltanto un inferno
in cui tutto è toccato e tutto ci tocca.
idea-éureka, buio: fulminata lampadina:
Eràclito è annegato
nel fiume. ho freddo:
porto questo figlio di legno
dentro: accendo il fuoco. in fondo,
pensare è un ventriloquio.
* éuteichos, trad. dal greco: ‘dalle belle mura’

*
#prisonbreak
ci dicevano che la pietra sarebbe fiorita,
che le cose, se pensate
migliori, sarebbero migliorate:
dicevano: fiume, acqua in preghiera
neve, zucchero in cielo
bene, frutto del vero…
eppure abbiamo mani vuote; e dopo anni
il vuoto diventa
pesante da tenere, quando facciamo silenzio
e succede poi sempre qualcosa: qualcuno
entra e lo rompe solo per vedere
cosa c’è dentro
– di solito utilizza come martello il meteo –
e così, con quest’uovo di vento e nubi
sparse sulle labbra, restiamo
per decenni ignoti al nostro sangue,
muti e interrogati
da quello che qualche risata o, per noi felice,
sguardo aveva significato.
di’ ai tuoi figli di non dire a nessuno
del vuoto che ti imbambola
le vene, e che tu devi bere
ogni mattino prima dell’acqua insieme
a un litro di bugie – di’ di non dire
che vivi in una gabbia
e che, per sopravvivere, tu – come tutti –
hai messo in carcere la tua prigione
perché il prigioniero principale
potesse fuggire; che non serve conoscere
i significati, se si sanno
le intenzioni, come a esempio
il bacio di tua madre sulla fronte
di mio padre.

*
Michele Lionetti (Cetraro 1993) è dottorando in ‘Scienze dell’Antichità e Archeologia’ presso UNIPI, si occupa di antropologia del mondo antico, diritti dell’antichità, lingua e letteratura greca, metafisica classica. I suoi interessi artistici vertono soprattutto in poesia e drammaturgia. È in uscita per la ‘Marco Saya Editore’ la sua prima raccolta di poesie e monologhi dal titolo O vivi o ti salvi.