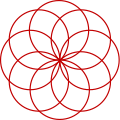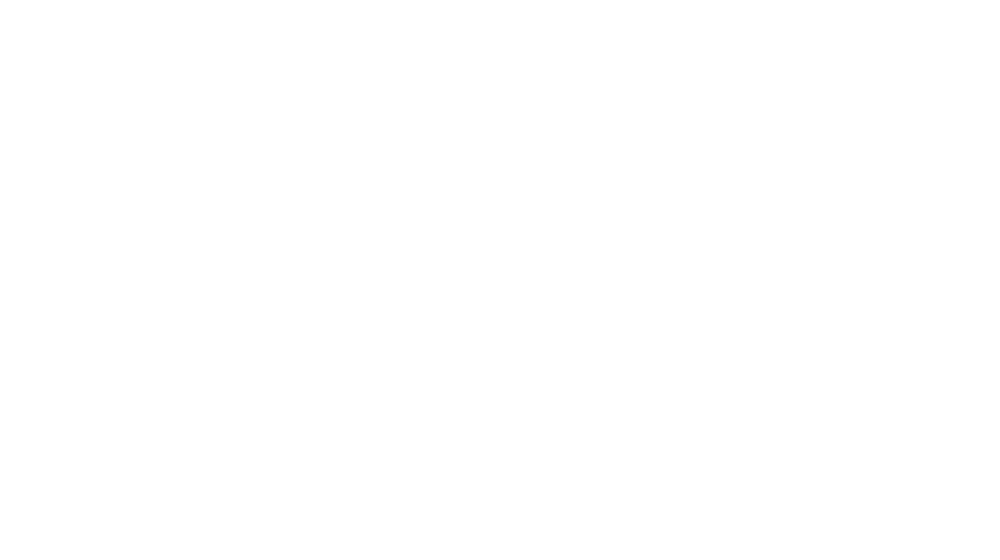“Ho provato anch’io. // È stata tutta una guerra / d’unghie. Ma ora so. Nessuno / potrà mai perforare / il muro della terra”. Con questi versi, in risonanza con la terzina di apertura del decimo canto dell’Inferno dantesco, Giorgio Caproni (Anch’io, da Il muro della terra, 1975) meditava il rapporto tra l’essere qui, in smarrita concretezza, e il “mistero dell’oltre”: questo esitava, nel poeta, in un principio di “inesistenza”, di inanità che affligge tutto e ogni dove, finanche l’ipotesi di una dimensione ultraterrena. A questa posizione di congedo faceva però da contraltare, in altri suoi testi, una postura contraria, di cui è buon esempio un’intensa lirica dedicata al figlio: “Rema con me negli occhi al largo / del tuo futuro, mentre odo / (non odio) abbrunato il sordo / battito del tamburo / che rulla – come il mio cuore: in nome / di nulla – la Dedizione”.

Di un tal genere di Dedizione che poggia nel nulla e da esso prescinde, similmente inscritta nel cerchio di un rapporto padre-figlio, ci mette a parte Giancarlo Sissa nella sua opera in prosa poetica Archivio del padre (MC edizioni, a cura di Pasquale Di Palmo, collana Gli insetti, 2020). Vincolo infranto dall’assenza, e insidiato da un affilato e laico sconforto, ma redento in vivida premura, in tenacia d’amore.
Perché, anche in questo ieratico Archivio, al senso di pura inesistenza e annullamento, di irredimibile perdita, si affianca, nel corso dell’opera, un’alba di cura e ricordo, casta celebrazione di un magistero morale inestinguibile: “L’operaio che amava i libri mi ha insegnato a leggere e a disegnare. A cercare anima ovunque. A mani aperte” e ancora “Mio padre sgusciava le noci con grande lentezza. Meditando lasciandosi. Meditare. […] Mio padre non aveva paura di niente”.
In Archivio del padre c’è un paterno esser dovuti andare, e un filiale dover essere qui, sentinelle straziate all’eterna migrazione di ciò che è caro. E il movimento bidirezionale del flusso e del ritorno: se l’angelo del padre è sempre presente ai giorni, così la materia si proietta nell’incorporeo con i suoi significati e simboli: “Quest’uomo seduto su una panchina nella piazza allagata dal sole. Quest’uomo che attende e ci parla lontano. Quest’uomo prima che arrivassimo era. La statua di mio padre. Antichissima nella luce e un giorno. La mia”.
Una somiglianza fisica e una spirituale concordanza a tal punto vibrate da portare a una trasfigurazione, che trova nell’esser “perdenti”, nel dichiararsi subalterni, un basso continuo di dignità e vitalità potente, che finisce per rovesciare le misure del mondo: “io e te papà siamo poveri. Lo siamo da secoli e lo saremo. Non c’era e non c’è nulla da tradire. Ognuno fa quello che può. Solo chi ha fatto. I soldi si è fatto. Lontano senza dire una parola come. Se non ci conoscesse. Mentre c’è. Ancora sole sulle dita”.

Trova anche spazio, nel poeta, un certo surrealismo, per cui la realtà è talora restituita colma di immagini inattese, forme acquattate nel paesaggio, che paiono alludere a una particolare etica delle cose: “La campagna che vedo dal treno tra Modena e Mantova milioni d’anni fa era il fondo di un oceano. E il ponte sul Po una balena fossile. O un sogno futuro. Se nelle ipotesi del passato ogni racconto giace sul fianco”.
Chaque être crie en silence pour être lu autrement (Weil), e così fanno gli elementi e le essenze naturali che vengono al poeta per ritornare materialità agente, che solleva azioni precise, orientando coi propri segnali le anime senzienti nel dedalo del vivere.
In particolare, la natura è l’invaso in cui palpitano le anime estinte, tutelari e silenti, quiete presenze che evocano la gestualità raccolta del padre: “Forse ogni fiume è un diario. Penso in prossimità del Po e ogni. Diario un campo seminato dai sogni dei padri. Perché nel nome di ognuno è contenuta la parola che tace”.
Controparte viva e presente, la creatura nuova è come piccola pianta, necessita di nutrimento, apertura, e generoso substrato, muro “caldo e semplice navigato”, custodia adulta e lenta, mediatrice di “gesti antichi e silenziosi”. La “linea madre” che unisce la creatura figlia con le sue radici e la sua prosecuzione traccia ogni anima del suo percorso di senso, scritto sul palmo come “gesto serio della gioia”.

Se nel fluire della vita risiede la sua sacralità, allora il cenno più esatto è la resa: sguardo vasto, che depone ogni resistenza, e con trasparente immobilità giace inerme a farsi guado e cristallo, sentiero, restituendosi pacati, lenti, operosi nel riserbo, celando quel po’ d’inquietudine che a ognuno è data, facendosi valle d’accoglienza, che non cerca affermazione, ma flette all’altro da sé: “Alzare le mani. Con lentezza. Pulire il ponte della nave. Che ci riposi. Di nascosto la prossima tempesta. Si spostino da me quelli che hanno. Ragione”.
Operazione reiterata, nel poeta, è esordire da paesaggi simbolici, abitati da essenze antiche, ultraterreni attraversamenti, inventari di lealtà in cui ogni scala di valori mondani si colma fino a rovesciarsi nel suo opposto, a planare in immagini nude e sognanti, pervase di alati simbolismi, dove l’innocenza è madre silenziosa: “Le barche si preparano alla nebbia del grande fiume. A raccogliere i bambini del secolo scorso. A salvarli da ignoranza e vanità da. Nidi senza piume”.
Il tempo sulla Terra è un attraversamento di desolazioni, la malattia è “lago profondo. / L’ago buio del male” e la morte una “riva”, ultimo indugio prima del grande mare che, mentre ci annienta, ci rinasce.
Cosa ferma, dilatata la morte, il corpo del padre nella bara è un “gesto enorme”. Morire è questo ricevere un battesimo inverso, “scandaglio luminoso” che ci trova nella nostra pochezza, “nome che porta via”.

Si collocano prima e dopo questa linea nettissima di trapasso i frammenti lirici di Sissa, a costruire un diario intermittente dove ricordi d’infanzia perforano il calendario e divengono pervasivi degli ambienti, delle meditazioni quotidiane, sfumando nei luoghi e negli oggetti, fino a farsi sogno presente e profezia.
Nello stile, molte le accortezze sintattiche, ritmiche, lessicali. Anafore e allitterazioni, sinestesie ed ellissi conferiscono alla prosa di Archivio del padre un sapore rituale, a tratti medianico, e un senso straniato di percezione eletta nel dolore. Un raccoglimento assorto in albe livide, acremente sofferte, ma numinosamente visitate.
Spesso la chiusa dei blocchi di testo è in assonanza o franca rima con ciò che precede, mimando un’ingenuità apparente, d’inarrivabile dolcezza melodica e concettuale: ribadisce armonia il poeta, a prescindere dalla sofferenza che appanna, ma la meraviglia abita le cose, e non si dà pensiero dell’uomo, delle umiliazioni ch’egli infligge al creato coi propri tornaconti.
Persino l’angoscia, in Sissa, è bellissima: “Quanta paura fa il padre buono. Dopo di lui non ci sono più scuse. Ci sfiora l’enorme silenzio buio di un veliero. A lume di candela nel ventre della balena” perché vi è sempre un adito, connessione, soffio di salvezza: “Per difetto del dispetto sei tornato a casa. In sogno il riconoscermi. Amico mio non importava”.
In questo caotico e doloroso esistere, il lutto è per la cura che manca: “Il dolore intermittente al polmone sinistro è Giancarlo che mi dice nessuno pregò. Nelle albe degli orfani per le celesti biciclette con le ruote sgonfie”: a tal proposito, nel saggio introduttivo Di Palmo nomina un “inventario” di oggetti a funzione metaforica, messi in salvo dalla dimenticanza: azione precisa di equità, se pur apparentemente parificata in “magmatica catalogazione”, che diviene portamento di “dialogo ininterrotto con le ombre”, e di sottrazione all’oblio di ogni “minimo segno”, recato poi sulla pagina come “fulmine” o “cicatrice”.

Questa apparente frammentarietà, che enumera temi, situazioni, stati d’animo, e si erge d’improvviso in miliari rivelazioni, mostra in realtà un’architettura sommersa, una postura unificante, che altro non preconizza se non, in netta controtendenza all’epoca attuale, un eversivo, ostinato aver amore e premura. Simbolo e simulacro, in questa potenza d’inermità, è Gianfranco, archetipo del Padre: uomo che conosce quotidiane nobiltà, vivido nei gesti, maestoso nei contorni.
Il ricordo del padre assume via via l’assetto di un percorso iniziatico, indicata condotta di vita, via bianca in ripido versante di errore: la dignità dimora nella propria riconosciuta fallibilità, che è costante redenzione: “E fallire parola. Dopo parola fino a rinascere. Tutto ha una importanza immensa”.
Nel legame, solo apparentemente interrotto, con il padre, si colloca un dialogo tenerissimo di lasciti fecondi, nel quale il tempo scorre inavvertito e inessenziale, in un continuo rovesciarsi del perenne nel contingente, del bambino nell’uomo, della paterna tutela nella fanciulla innocenza: “Mio padre è un bambino che passeggia in riva al lago con tutti gli amici di un tempo. Che occhi luminosi che ha colore d’acqua d’inverno si chiama papà”. Il Padre, modello etico, è altresì monarca di una vallata giocosa di passatempi colorati: prestigiatore di gioia, a suturare il male.
Due poli emittenti guidano l’andare: il padre, luminoso in presenza, e la natura, che contiene precise affermazioni, continuo Evangelo che invita a correggere la notte secondo esatte lealtà, facendo capo al senso del vivere: “In cielo ci sono i segni del grano. Quante cose scrive la pioggia sui quaderni […] Si può ridere delle domande. Le domande dicono chi toglie il dolore dal mondo. A chi ride il ridere resta”.
Sissa, dilatato dalla perdita, aderisce al patto più alto, e rovescia il castello di stracci dei finti valori, che fanno dell’uomo presente una creatura larvale, arruolata al consumo: “Ho le gambe piene di morsi padre mio. Piene di scommesse perse. // Nel ringhio della povertà completa. Così piena di vita”.

Se il futile erige il suo impero d’infelicità, con “soggetti che gridano al cellulare verso nuovi continenti e cagnolini che abbaiano in ossequio a”, è pur vero che la vita si dà respiro in silenzio, in luoghi esanimi, caparbi di bontà: “e intanto sul balcone. Sotto la bicicletta nella pioggia arrugginita. Un piccione ha deposto due uova. Pallide come l’insonnia”.
“Compiti severi” assegna l’esistenza, e molto chiede a chi riesce a elevarsi dalla propria materialità, a congedarsi dal presumere diritto e ragione, per issarsi fermo nel vuoto che osserva, e ospita, e rimane.
“Chi esce vede segni inaspettati” diceva Mario Luzi, e ancora: “Il paesaggio è quello umano / che per assenza d’amore / appare disunito e strano”; ma anche: “Il tempo adduce e porta via le forme, / il tempo ci dà vita e ci distrugge / mentre immobile vigila l’essenza”.
Compito severo di presenza spoglia, e anelito all’ascolto, che, pur nella dichiarata laicità del poeta, rivela anfratti di luce cristica. Se Luzi ancora recita: “Prima che questa pena migri altrove / soffrila, è tua, si duole in te la nascita / incessante del tutto ingenerato, / il moto nella quiete, il divenire / in quel che è, che resta sempre uguale”, Sissa risponde con una parallela “perfetta guarigione”, che è analogo abbandono al fluire del creato, pur nel ribadirsi “periferico” in unicità, particella insorta a eccezione della macchina, briciola spavalda nel bene: “Il granello che inceppa. L’arma. Il refolo di vento. Caduto dalla tempesta […] perché l’ordine cronologico è una poetica naturale. Dove cade nella carne. Tutto. L’abisso. Tutta la santa. Malinconia. Dell’acqua”.
Movimento, flusso, viaggio. Solo il pellegrino che si smarrisce può essere profeta. Ecco Sissa nella sua recente, sereniana, Frontiera: “Il fiume è lontano alle mie spalle, mi guardo le scarpe infangate, ho la barba lunga, gli occhi pesanti. Ho bisogno di dormire. Acquisto verità nella fatica del mattino. La voce come una preda invisibile indica l’azzurro silenzioso dei laghi, il pugno che sfonda la porta […] La mia casa è sulla frontiera di quel che conosco”. (Giancarlo Sissa, Frontiera, Babbomorto Editore 2022).

Sissa è il poeta della fatica e del cammino, tenace a dismettere la vittoria, a ripudiare l’inautentico, fino a segnare crinali bianchi, altissimi. Anche la rabbia del retaggio, orgoglio operaio di fuliggine e pietra, archeologia delle mani, diviene sguardo terso e smisurato perdono. In Autoritratto, che antologizza la sua produzione precedente, scaturita da oltre vent’anni di meditazione poetica (1990-2012), accadeva qualcosa in chiusura, nella doglia del “diluvio dei corpi”, nel crollo di “alba senza pazienza”, e nella paura che è “neve nera”: era qualcosa che nasceva dal patire, e che accendeva un lume inatteso. La casa del dolore nel costato, in un fiato di volo, si faceva grazia, e l’“antica bestia” che tutti siamo, trovava nella sofferenza la sua riconsegna, via di pace.
E così ora, nell’Archivio del padre, la strada è nitida, diritta: “Allora resto nel bene. Della lotta pronto. Alla sconfitta. Arreso. Morto. Invincibile”.
Nella caduta del corpo, colui che elegge a luce la sconfitta traspare estinto al mondo, invitto in spirito. Miracolo di residuo gettato in ala, morte a risveglio bianco, “tuono silenzioso” di poesia intrisa di amore assoluto, veste lieve di perfetta guarigione.
Isabella Bignozzi
*
Martedì 13 novembre 2018
Scrivere e tacere padre caro quello. Che succede è che si parla troppo. E male che ci si scorda che. Non si capisce più tanto. Perché è così che funziona verso l’inizio. Nelle luci dell’acqua piena di cielo. Capire meno costringe a cercare nuova casa. Pietà per i padri che si rompono. Le parole che circondano la parola padre come acqua del mattino.
*
Giorni prima
Ho la voce piena di altalene. La schiena piena di febbre. I miei avi piallavano e incollavano violini. I miei avi inchiodavano e risuolavano scarponi. Abbandonavano figli. Rassettavano camere d’albergo. Mangiavano la terra.
Undici ottobre giorno primo di luna crescente.
Alba che fa lievitare la morte nel cuore.
Quindici ottobre. Fiamma limpida e severa. Volo preghiera.
*
Ascoltare il cielo serve per credere. Che nevicherà ancora. Quel sale di luce. Che cuoce il pane accanto. Al fuoco dei giorni. Nei monitor della sconfitta. Avessimo solo. Un po’ più di passi. Verticali. Verso i fiumi altissimi. Del ricordo. Del grande. E gentile prima. Avessimo un cielo ancora. Da pregare. Con mani. E occhi. Con lo sguardo acceso nello sguardo. Potremmo chiamarlo sottovoce. Sorridendo lentamente. Risveglio.
*
Giancarlo Sissa è nato a Mantova nel 1961. Vive a Bologna. Come poeta ha pubblicato nel 1997 Laureola (Book Editore) con postfazione di Alberto Bertoni, nel 1998 Prima della tac e altre poesie (Marcos y Marcos) con prefazione di Giovanni Giudici, nel 2002 Il mestiere dell’educatore (Book Editore) con postfazione di Alberto Bertoni, nel 2004 Manuale d’insonnia (Aragno) con postfazione di Roberto Galaverni, nel 2008 Il bambino perfetto (Manni) con postfazione di Antonio Prete, nel 2015 Autoritratto (poesie 1990-2015) (italic/pequod) con postfazione di Alberto Bertoni e Persona minore (qudulibri), nel 2020 Archivio del Padre (MC edizioni) con prefazione di Pasquale Di Palmo. Nel 2004 ha ideato e curato il volume Poesia a Bologna (Gallo et Calzati Editori).
È presente in diverse antologie fra cui L’occhio e il cuore, poeti degli anni ’90 (Sometti 2000), Il pensiero dominante, poesia italiana 1970-2000 (Garzanti 2001), Le parole esposte, fotostoria della poesia italiana del Novecento (Crocetti 2002), Poesia della traduzione (Sometti 2003), Parole di passo, trentatré poeti per il terzo millennio (Nino Aragno 2004), Trent’anni di Novecento (Book Editore, 2005), La linea del Sillaro (Campanotto 2006), Vicino alle nubi sulla montagna crollata (Campanotto 2008), Calpestare l’oblio (Argo, 2010), 100Thousand Poets for change primo movimento (qudu libri 2013), I volti delle parole (Fondazione TitoBalestra onlus, fotografie di Daniele Ferroni, prefazione di Sebastiano Vassalli 2014), Non ti curar di me se il cuor ti manca (qudulibri 2015 e 2016), Sulla scia dei piovaschi – poeti italiani tra due millenni (Archinto, 2016), Passione Poesia – Letture di poesia contemporanea 1990-2015 (Edizioni CFR 2016), Centrale di Transito (ceci n’est pas une anthologie) (Giulio Perrone Editore 2016), Officine della Poesia 1. Bologna (Kurumuny Editore 2018), Verso le sei di sera in Corte Dandini (peQuod Editore 2018), Ritratti di poeta (puntoacapo Editore 2019), Sospeso respiro – Poesia di pandemia (Moretti & Vitali 2020) a cura di Gabrio Vitali, Distanze obliterate – Generazioni di poesie sulla rete (puntoacapo Editore 2021).
Dalla collaborazione con il fotografo Daniele Ferroni sono nati nel 2019 L’ultimo ballerino dell’aia tradotto in russo da Kristina Landa con prefazione di Giampiero Neri e postfazione di Vittorio Cozzoli (Edizioni Lumacagolosa) e nel 2020 Lentezza e silenzio e Il silenzio (Edizioni Pulcinoelefante). Del 2019 è le plaquette Il lupo (Babbomorto Editore) e del 2022 è Frontiera (Babbomorto Editore, 2022).
Le sue poesie sono tradotte in diverse lingue europee.
Per anni ha prestato opera di “diarista e narratore in scena” per il Teatro delle Ariette e nell’ambito del progetto teatrale Rosaspina, il tempo del sogno di Alessandra Gabriela Baldoni.
Dal 2010 conduce atelier di scrittura dedicati alle tematiche del Silenzio, della Sincerità, della riflessione autobiografica in prosa e in versi in Italia e all’estero.