
a cura di Maurizio Cucchi, Stampa 2009
Il “Primo piano increspato” che Emilia Barbato convoca a proposito dei suoi versi (Emilia barbato, Primo piano increspato, a cura di Maurizio Cucchi, Stampa 2009) richiama, a livello inconscio, molte immagini: un dipinto Nihonga per esempio, in cui le forme della natura, per progressiva spoliazione, giungano prossime alla propria essenza; e sorgano, nel tratto sognante e sfumato, a percezione spirituale del proprio divenire, laddove corolle e nebbie, nobili profili e paesaggi trascendenti posino su supporti di carta o seta di studiata ruvidità.
Tuttavia l’immagine sovrana è la superficie duttile, appena segnata dall’impronta del reale, di una creatura quieta, tacita, che, nell’essere piano, prenda forma al conio dell’esistere, e divenga substrato di un incedere avvertito e pacato, in sussurrato chiarore.
“A te che conosci la paura e il pianto del primo fiore” recita un passaggio in epigrafe, e tant’è. Vi sono essenze vive cui solo certi sguardi rivolgono attenzione, ma non per questo sono diminuite o esigue in esistenza, anzi. La dignità di chi dura in lealtà, senza conformarsi ad aspettativa alcuna, senza aggettare volontariamente nello spaventoso ribollire del mondo, eppure portandone presenza e peso, pare, in quest’epoca smarrita, il solo residuo di ogni creaturale senso.

Sotto questo “primo piano increspato”, rilkiani spazi interiori sembrano dilatarsi in accoglienza e accudimento ovattato, nella mai conclusa presa di coscienza del dualismo, tutto umano, tra avvilita, labile corporeità e intatto spirito; pur sopito, quest’ultimo, in frammentazione, in trascuratezza: “In un primo piano increspato / muove lo sguardo, proibita/ tunica e lira del silenzio. […] Sa del primo nemico / e della natura divina insieme”.
Quella parte di risveglio che è donata al singolo – avvinto a retaggio d’impronta, ma col “resto del corpo calmo, / imperturbabile” – non può che traslare in assenso alla propria caducità: “minuto di mito” l’uomo, se solo sapesse regarder, tout en restant à côté de son propre corps (Cristina Campo), potrebbe sentire “liquida / una calma, / l’onda del vento”, e conquistare quel “doppio sguardo”, affilato in sapienza suprema, che salva dall’irredento dolore: vedersi passare, versando “di anfora in anfora un torbido / momentaneo sul mare”, senza compiutezza, né rilevanza alcuna, nell’economia immobile dell’universo.

“Passo di polvere” dalla “natura immoderata”, l’umanità in ciascuno dei suoi membri ha il potenziale, in gran misura inespresso, di evocare in sé la reminiscenza di ere oscuramente feconde, nel misterioso magistero di sangue di quel divino femminile che tutto genera e patisce, che tutto pervade e riguarda.
Barbato sembra accogliere l’invito che posa nell’iride dell’essere, e muove verso il centro del cerchio: con portamento epigrafico, tra morbide oscurità e subitanei disvelamenti, la poetessa prende dimora nel chiaroscuro, ed elargisce tracce a intermittenza, con piglio a tratti cosmologico, eracliteo: “Da molto lontano l’uomo risale / il passo è limite / il corpo un’impressione d’aria. / Soffia quel poco sul vasto / poi ridiscende. Se ne va / instabile, lieve.”

Emilia erige il proprio dettato, scandito da miliari arcani, in metafore ortogonali alla linearità del tempo, abissalmente radicate nell’inconscio collettivo, facendole affiorare alla rappresentazione corticale mediante visioni piumate in acquerello, stilate in tenui cromatismi, con portamento Iki, di altera e misurata armonia.
Si avverte morbido, senza rivendicazione alcuna, il ripiegamento in una diversa dimensione, franca da chiassose sregolatezze, un’immersione in lidi placidi, per nulla inerti: “ambizioni privatissime”, ma d’ambizione mondate, in cui l’accantonamento dell’io non è sparizione al mondo, ma mescolanza e discioglimento in materia fluttuante, afflato di fusione e rinascita, in fedeltà e nativo ritorno.
Il mistero del “pontile” porta avanti un’intera sezione di meditazioni lirico-narrative, e ricorre come aperta tenebra dai profili mutevoli, come oscuro simbolo salvifico, segno e figura potente, con sapore di celaniana mandorla, o papavero, o conchiglia.
Pontile che è varo e approdo, via che segna le acque e in esse discende, che si lascia lambire ma, nella sua nudità disadorna, posa con snella, lineare tenacia, dura in umile, ostinata permanenza: piattaforma morale dell’artista, che lo tiene tra le mani e ne è tenuto, custodito in recondita solitudine.
Nondimeno il pontile è ciò che rimane quando la massa si denatura e decade, quando il passo umano si fa conscio della propria aleatoria incertezza: è il gracile cammino che resiste, tra le acque, auspicio che riaffiora, indenne all’illogico e indecifrabile, al moto ondoso di eccessi e carenze.
Il rientro nella moltitudine, sembra dire la poetessa, ha profilo più nitido dopo aver visitato i propri anfratti spirituali, le intricate stanze che affiorano nel “giardino selvatico” degli occhi con brada unicità. Essere in contatto con il proprio domicilio interiore consente una percezione più tersa della propria identità, ma anche miglior osmosi con la realtà esterna: il soggetto che conosce la “la trama / intima delle cose, / le geometrie dell’acquitrino”, si ridà al mare “quieto della propria appartenenza”, allontanandosi dal pontile “in creste d’argento”. Ed è così che il rapporto col creato si fa oscillante e dialettico, ribadendo quel rilkiano Weltinnenraum che, a partire da un intimo regno visitato, si fa accoglienza verso l’esterno, e intimità con le cose.

Se il poeta vive una dimensione sospesa, sintonica col teatro naturale, l’incontro con le installazioni umane – allegorizzate in un lussuoso e stralunato hotel, che dà il nome all’ultima sezione – appare spesso inavvertito, precipite: “All’ingresso nessun usciere apre / la porta di vetro che separa i due mondi // in uno strepito di voci e metallo / il ritorno nel presente / quel fiore di stoffa / rosso alle radici”.
L’essere umano, esule e intontito, in tale scenario brevemente si mostra, creatura residuale, piegata a una linearità (l’abbondanza, le progressive sorti, la celebrata crescita) che lo asserve illudendolo: nello spettrale hotel, l’uomo è “incanutito tra pasti e bevande. // Il tempo è precario, i clienti, / caduchi come rami, / hanno un portamento strisciante”.
Ora, sul linguaggio di Barbato: colpisce un’attenzione lessicale così esatta da farsi etica del dire: nominare le creature e la conformazione del territorio con il nome univoco che a loro naturalmente pertiene è un riconoscimento di identità devoto al creato, intenso atto di ascolto, che irradia preciso sulle cose. Qui, con desiati ed evocati echi danteschi: “il letto si fa fiume giù per la bassa / padana e trova alneti, lame e bassure, / echi lontani di un verdone, del verzellino”.

E ancora, la poetessa avverte e riporta un sentire intento, orientato: il particolare, finanche l’ombra posata sul muro, ha in sé un potenziale ontologico tremendo, che solo una percezione perfetta, e qui sta il paradosso, può esorcizzare, portandone ogni furia alla coscienza: “il buio sul tramezzo / preda la seta felice dei sogni” con tutto il rischio che questo implica: il rischio della poesia.
Se, dal migrare poetico della mente, il ritorno agli spigoli del giorno è diaccio e contorto, è pur vero che ciò che risplende nel creato distende la propria intensità cromatica risalendo a ritroso la via di una sorgente. Qui nasce la tensione del poeta, cui non interessano paratassi e ipotassi del dire, né la struttura del singolo lemma che, se perde in essenza, diviene “fossile, / lo scheletro di un suono che si ripiega / in un cerchio d’osso”, ma il soffio che abita l’etimo da tempi immemori, il bagliore che ancora arde ignorando la coltre opaca del tempo spento, valicando “la lunga assenza della materia”.
Il “verbo remoto” che “la lampada […] fruga nella polvere”, chiama a sé l’essenza minima, precaria, della creatura più fragile e breve, già deteriorata e spoglia, in cui si centra l’orbita di ogni cosmica meditata consapevolezza.
Barbato è una poetessa elevata e, come tale, indifesa, che si prende il rischio di non essere interamente capita, perché nel garbo di disciplinati diagrammi sintattici, nella conservata grammatica, fluiscono libere essenze agenti con potenza incorrotta, anteriore alla logica, dove balenano significati emotivi e sensoriali preverbali. La poesia di Barbato è un invito nel mondo dove le cose volteggiano sospese o fluiscono senz’argine, ricolme di quella vastità educata che attende con pazienza; se visitate, queste sponde, pur sottovoce, tintinnano in soffio e propagano inestinguibili riverberi di senso, come ogni indecifrato simbolo.
Isabella Bignozzi
Da Primo piano increspato a cura di Maurizio Cucchi, Stampa 2009 Editore
Avremmo dovuto restare segreti,
un po’ dimenticati come locande
remote di campagna.
Avremmo dovuto essere fitti muschi
insinuarci nelle clavicole, avanzare piano,
molto piano, con le dita.
*
Minuto di mito l’uomo versa
di anfora in anfora un torbido
momentaneo sul mare.
Rombo d’onda si frange
in rosse e grosse bugie
calcando l’ombra dell’immortale.
*
Più aspro
– agito dall’energia dei venti,
selvatico come lavanda
lambita dal ritmo dei canneti –
l’ansito
lontanissimo chiama dalla terra,
idea inalterata di origine,
mistero, identità di isola, ombra
nera di vecchie femmine.

*
Il silenzio
non ha che il corpo in cui raccogliersi,
liquida
una calma,
l’onda del vento.
Da una tela di tre ragni
vorremmo cogliere i simboli della stele
ma ci arriva una pace di pietre,
la grazia che l’occhio contiene.
*
Anima
Al lato opposto della corona,
in bianco e nero posa
nudo il pontile nelle mani dell’artista.
Le occasioni di chi ama la solitudine sono misteriose, profonde

*
La vernice chiede al croco
la memoria dei suoi stimmi,
all’eliotropo quel colore su cui riposano
chiarori e trasparenze che colmano
la lunga assenza della materia.
La parola è un fossile,
lo scheletro di un suono che si ripiega
in un cerchio d’osso,
un’essenza vuota di zafferano
*
Dallo scrittoio la lampada
memore di una fosforescenza
fruga nella polvere un verbo
remoto, ma nomina appena
le orbite di una falena, il peso
irrisorio dei suoi resti.
Emilia Barbato è nata a Napoli nel 1971 e risiede a Milano. I suoi testi sono apparsi in diverse antologie, sulla rivista «Il Segnale», «Poezia» di Bucarest, «l’immaginazione» delle Edizioni Manni e sull’«Aperiodico ad Apparizione Aleatoria» delle Edizioni del Foglio Clandestino. Geografie di un Orlo (CSA Editrice, 2011) è la sua opera di esordio. Seguono Memoriali Bianchi (Edizioni Smaher, 2014), Capogatto (Puntoacapo Editrice, 2016, I classificato alla sezione Libri Editi della IX edizione del Concorso Nazionale di Poesia Chiaramonte Gulfi – Città dei musei), Il rigo tra i rami del sambuco (Pietre Vive Editore, 2018), Nature Reversibili (Lieto Colle, 2019).
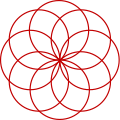


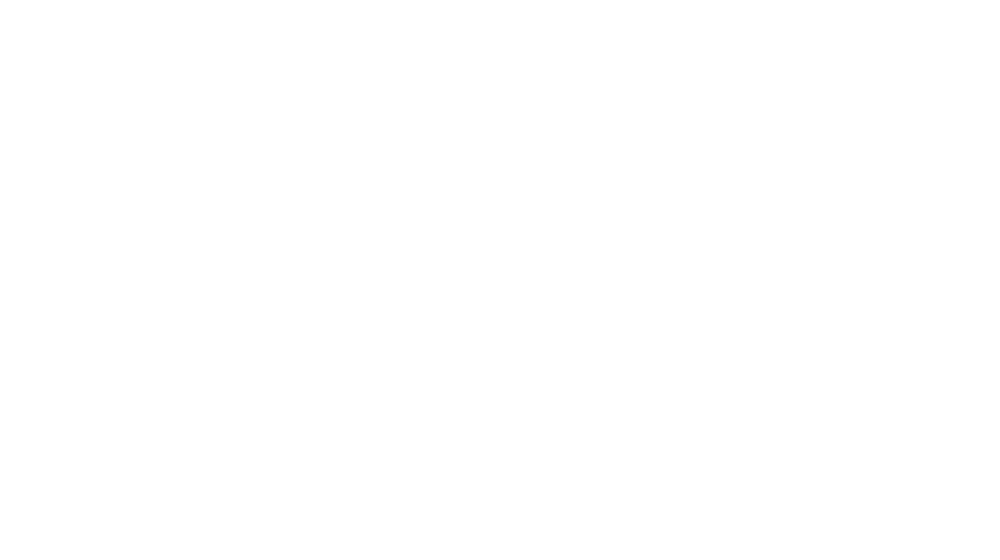

1 Commento