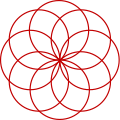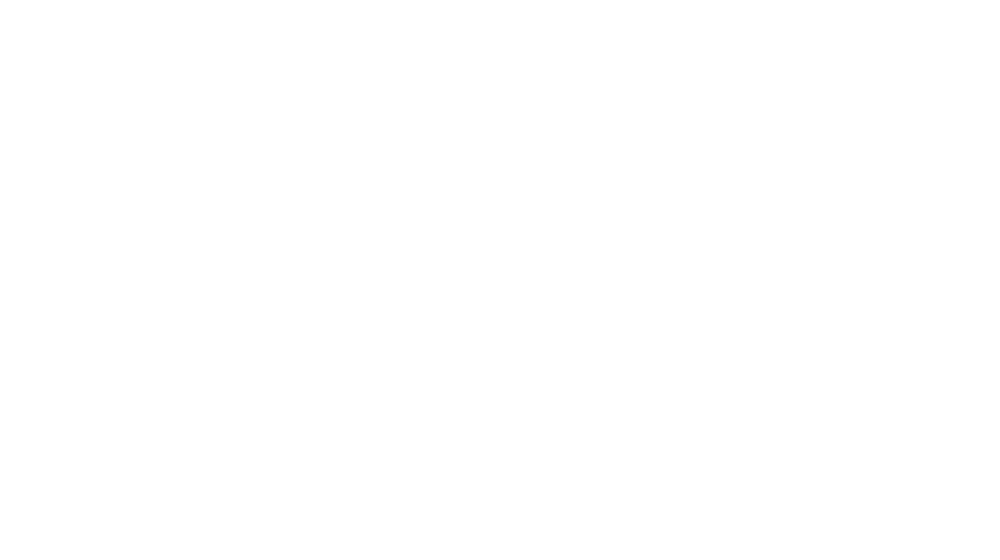Philippe Jaccottet
Philippe Jaccottet su Giorgio Morandi
a cura di Grazia Frisina
[…] È ormai tempo di affrontare quelle opere che mi hanno reso infedele al voto, più di una volta confessato e professato, di non scrivere mai nulla attorno all’arte. Di fronte ad esse, si può immaginare che Morandi monologasse in questo modo (ci si può arrischiare, pur sapendo che non l’avrebbe mai fatto in questi termini): “Altri hanno celebrato la ricchezza, la varietà, il bagliore del mondo, e l’hanno fatto dispiegando tutta un’orchestrazione complessa di colori e di forme; questo non era nella mia natura, e forse non è più neppure ammissibile ai nostri giorni. Ma se si voleva ottenere, con dei mezzi infinitamente più poveri e con un registro più limitato, un risultato simile al loro, era necessaria una concentrazione proporzionalmente più grande. Ho voltato le spalle al mondo (rinunciando a vivere quel che si dice la vita, o poco ci è mancato); mi sono rinchiuso in una sorta di cella con pochi oggetti, perlopiù banali e che non richiamano neppure, come quelli che aveva scelto Chardin, ‘la vita umile dai lavori facili e noiosi’; ma che rimarranno per sempre degli oggetti, senza mai tramutarsi in pure forme come accade negli astrattisti…”
Ovunque, cenni: i lillà ansiosi di vivere
e i bambini che smarrivano i palloni
dentro i parchi. Poi, quelle zolle rivoltate lì vicino,
che denudavano, radice su radice,
l’odore di donna stanca… Nulla, inezie,
con cui l’aria tesseva la sua tela
tremante… E io la laceravo
a furia d’esser solo e cercar tracce

Per lungo tempo, Morandi ha dipinto come dei fregi di oggetti giustapposti (cinque, sei oggetti, anche di più talvolta); con gli anni, il loro numero è diminuito, la composizione si è concentrata sempre più, facendosi sempre più persuasiva […]
È fluido questo verde, trema, brilla,
come zampillo d’acqua di fontana,
sensibile anche al minimo spiracolo; e uno sciame
sembra si sia posato in cima all’albero,
d’api ronzanti; paesaggio leggero
in cui ci chiamano uccelli mai visibili

Poiché sto di nuovo sfogliando adesso il catalogo dell’esposizione di acquarelli presentata a Firenze, a Palazzo Medici, nel 1991, la mia ammirazione cresce, pagina dopo pagina, fino a una sorta di stupore: quest’arte in sordina, quest’arte del nulla o quasi, paradossalmente, mi porta all’acclamazione. Pagina dopo pagina, il che vuol dire, più o meno precisamente, anno dopo anno, mese dopo mese, si ha l’impressione di salire sempre più in alto, verso una vetta. E le prime parole che vengono alla mente per qualificare questi piccoli fogli saranno “nobiltà”, “eleganza”, “altezza”; non posso farci nulla.
Per via di questo movimento ascensionale, di questi gradi successivi, ho pensato del tutto naturalmente a Dante, ai canti del Purgatorio e del Paradiso; il che non significa, sarà necessario dirlo?, che io intenda paragonare queste opere, e ancor meno che voglia issare Morandi accanto a Dante in un nuovo Parnaso, cosa che sarebbe assurda.
E tuttavia si è creato nella mia mente un accostamento più preciso, se non più legittimo, derivato da una frase, che nella mente appunto galleggiava, del critico Cesare: stendere sui muri di un’impossibile “sala della Pace suprema”. Una luce ad un tempo interiore e distante che potrebbe confondersi con un’infinita pazienza.
Chi sa la leggerezza che è nei semi
esiterebbe ad adorare il tuono.

Altri accostamenti, altre approssimazioni mi sono venuti alla mente guardando, presso il museo di Bologna, un paesaggio del 1962, piuttosto tardo dunque, la case di Campiaro viste di fronte. Sulle prime, ho rammentato i versi quasi troppo celebri di Paul Valéry: “Patience, patience, / Patience dans l’azur! / Chaque atome de silence / Est la chance d’un fruit mûr!”; per via della silenziosa pazienza che permette la maturazione delle opere d’arte, per via della parola «pazienza» che è così bella e che si addice così bene a questi paesaggi, come al resto dell’opera, e che chiama ancora a sé la parola «patina». Ma Valéry parla troppo bene, sembra di vederlo col gomito appoggiato al camino di un salotto, e bisogna subito, qui, dove non ha nulla a che vedere con il nostro discorso, dimenticarlo.
Conserverò soltanto la parola “pazienza”. La luce sorda, uguale, che qui regna e che si esita a dire se mattutina o serale – piuttosto mattutina, forse, per via d’un sospetto d’attesa –, una luce come interna alle cose, simile a un filo di lana che saprebbe tessere insieme ogni cosa: case, alberi, sentieri e cielo […]
Vedo, a grande distanza,
la strada coi suoi alberi e le case,
e il vento fresco di questa stagione
che spesso muta senso. Una carretta
passa con sopra dei mobili bianchi
nel sottobosco d’ombre.
Davanti vanno i giorni, e quel che resta,
mi basta poco tempo a farne il conto.

“Monacale”: il termine ricorre quasi immancabilmente negli scritti di coloro che hanno conosciuto Morandi o che cercano oggi di tratteggiare la sua figura.
Può darsi che si sia persino abusato di questo accostamento, col rischio di idealizzare l’uomo, la cui vita quotidiana, tanto segreta, rimane assai poco conosciuta. Il termine non cessa ciononostante di fluttuare nel nostro spirito riferendosi a lui, insufflatoci com’è dalle opere stesse. È vero che la vita di Morandi risulterà quasi altrettanto immobile, silenziosa, regolata, ripetitiva persino, di quella d’un monaco.

Tuttavia, il suo compito non è stato né la preghiera, né il canto, né lo studio dei Libri sacri o dei Padri della Chiesa, né la cura dei miseri e dei bisognosi, bensì, esclusivamente, la pittura; e una pittura dalla quale sono completamente scomparse non solo le persone divine, gli angeli e i santi – con tutte le loro storie, ma persino il volto stesso delle creature. (Ciò che potrebbe far pensare, a torto, che l’autore, di queste ultime, non si preoccupasse poi molto.)
Quest’aria che non vedi
porta un uccello lontano
e, senza peso, i semi
da cui crescerà domani
il margine dei boschi

Talvolta vi appaiono dei colori particolarmente austeri, invernali, di bosco e di neve, che daccapo ti fanno pronunciare la bella parola «pazienza», che ti fanno pensare alla pazienza dei vecchi contadini o a quella del monaco, con il suo saio bigio: un silenzio simile a quello che regna sotto la neve o tra i muri di calce di una cella. La pazienza che significa aver vissuto, aver penato, aver “resistito”: con modestia, sopportazione, ma senza rivolta, né indifferenza, né disperazione, come se, dentro questa pazienza, si attendesse nonostante tutto una sorta di arricchimento […]

I mille insetti della pioggia hanno lavorato
tutta la notte; gli alberi sono fioriti di gocce,
il temporale è un rumore di frusta lontana

(ndr dalle parole di Giorgio Morandi, come immaginate da Philippe Jaccottet)
“… mi ritrovo insieme a loro nel mio atelier, si fa un grande silenzio dentro di me ed attorno a loro, come se rileggessi L’Infinito dove, ai ‘sovrumani silenzi’ immaginati al di là della siepe, Leopardi ‘compara’ – e si può dire oppone – la voce del vento che passa attraverso il fogliame; riconoscendo di trovare qualche dolcezza nel naufragare in pensiero dentro lo spazio illimitato (e componendo così una variazione lirica sulla frase di Pascal di cui ogni parola – ogni nota musicale – si ritrova nella poesia: ‘Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa’).

“Nel silenzio, che è per me una necessità e un beneficio, si dissimula sempre, in effetti, una minaccia; per fronteggiare la quale, nel cuore stesso del silenzio, mi sembra tuttavia di aver trovato qualcosa, nel denudamento che ho scelto e voluto.
Nulla di nuovo, lo so bene. Tutti coloro che hanno disegnato e dipinto, sin dai primi arrischiati tratti sulle pareti delle caverne, hanno fatto, coscientemente o meno, la stessa cosa: opporre dei segni fragili, uno stormire di vento tra le foglie, al vuoto che li minacciava. Ma, con il trascorrere del tempo, le grandi feste di colori sembrano divenute menzognere, come le armonie felici concesse unicamente dall’illusione di un ordine universale.
Da allora in poi, alcuni credono di trovare nella derisione, o nella rabbiosa distruzione di quelle feste, di quelle forme splendenti, una sorta di verità; ma la derisione non fa che affrettare il naufragio. Altri, con un curioso balzo a ritroso, al di là del Rinascimento e dei Secoli aurei, immaginano di poter produrre una nuova magia scimmiottando l’arcaico, in tutte le sue forme. La via che ho scelto di seguire è più discreta, più segreta…”
(Luccicante, c’era un canale da seguire,
il canale della fabbrica, e si gettava un fiore
alla sorgente, per ritrovarlo in città…)
Ricordo d’infanzia. Mai uguali le acque, mai,
uguali i giorni: e chi prendesse l’acqua tra le mani…
Si accende un fuoco di rami sulla riva.

[…] Avendo un giorno osservato che la scodella bianca di certe nature morte mi faceva pensare ai monaci poeti del Giappone, sono stato lieto di scoprire, in una “scena” composta da Jean-Christophe Bailly per la Fondazione Magnani-Rocca di Parma allo scopo di evocarne le collezioni, queste parole, ispirate dall’insieme delle tele di Giorgio Morandi: “…come se la pittura diventasse una specie di cerimonia del tè, ma per gli occhi – l’arte di lasciare in infusione le foglie della sensazione nell’acqua del distacco…”
Ma sotto le dita s’apre la distanza,
si spezza come paglia il dolce sole.

A cura di Grazia Frisina
*
Testi consultati:
Le parti in prosa sono tratte da Philippe Jaccottet, La ciotola del pellegrino, traduzione di Fabio Pusterla, Casagrande Edizioni, 2007
Tutti i versi sono tratti da: Philippe Jaccottet, Il barbagianni. L’ignorante, a cura di Fabio Pusterla, con un saggio di Jean Starobinski, Einaudi editore 1992
Le immagini sono state digitalizzate da I maestri del colore, Morandi, a cura di Dino Fabbri, Alberto Martini, Renata Negri, Fratelli Fabbri Editori 1964