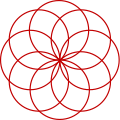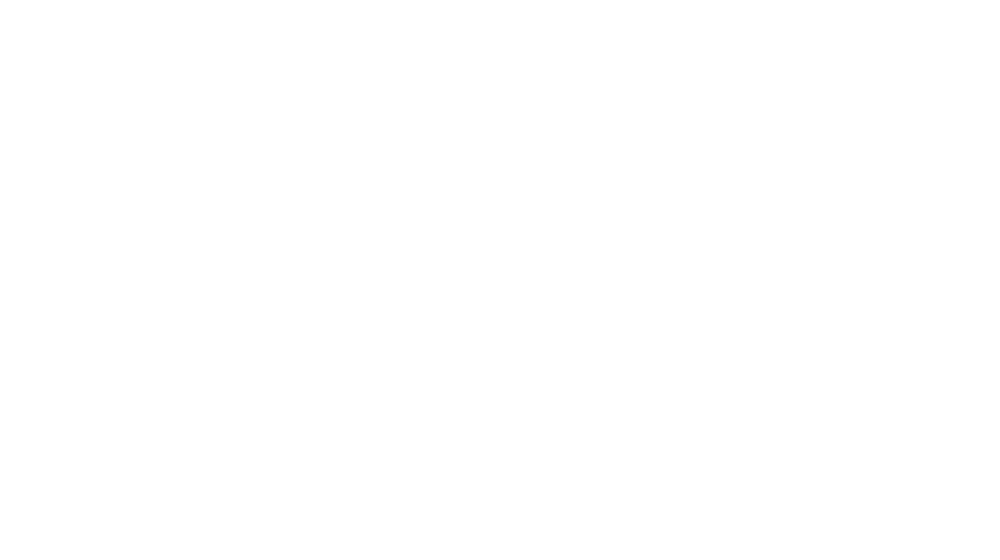Le parole come da un altro mondo
La poesia può essere criticata solo dalla poesia. Un giudizio che non sia un’opera d’arte non ha diritto di cittadinanza nel regno dell’arte.
Friedrich Schlegel
Che la poesia parli del mondo in cui vive, del mondo reale, del mondo inventato, transeunte, pericoloso, possibile, impossibile, esistente.
Cees Nooteboom
Quattro versi di Robert Walser ci presentano questa nitida immagine:
Tutto è silenzioso e bianco:
un grande splendido deserto
il cui freddo silenzio rende vano
ogni commento. Dentro di me avvampo
È paradossale e significativo avvampare davanti a un deserto bianco e freddo, silenzioso, entusiasmarci del nulla che la poesia sempre evoca, portandoci a navigare tra dissolvimento e conservazione della parola. Il poeta, da sempre, mette al centro della scena il dissolversi del mondo e il dolore della bellezza che svanisce, del tempo che ci ruba alla vita. Sigmund Freud scrive: «Il poeta ammirava la bellezza della natura intorno a noi ma non ne traeva gioia. Lo turbava il pensiero che tutta quella bellezza era destinata a perire, che col sopraggiungere dell’inverno sarebbe scomparsa: come del resto ogni bellezza umana, come tutto ciò che di bello o nobile gli uomini hanno creato o potranno creare. Tutto […] gli sembrava svilito dalla caducità a cui era destinato».

Il poeta non desidera riappacificarsi né con il mondo né con le parole. Tratta con le ombre e ne ricava luci. E quelle luci devono essere ri-accese, a costo della vita. Deve essere lui a ri-accenderle. Se non fosse così, non sentirebbe neppure l’impulso a scrivere, la necessità di colmare una mancanza con il sogno delle sue parole. Baudelairianamente, il suo è un “cuore messo a nudo”. A nervi scoperti, va alla ricerca di qualcosa che ancora non conosce, intorno a cui non riesce a fare chiarezza, pervaso da una febbre senza oggetto. La poesia si confronta con la necessità di questa febbre, con la sua sospensione visionaria, senza la quale l’impulso a fare arte non avrebbe alcun senso. La poesia è sperimentare emozioni che ingorgano, nodi che soffocano il respiro, e poi farli emergere nel testo, illimpidirli, ridurli in parole. Ogni poesia è dissipazione, dispersione, desiderio di libertà, energia destinata a dissolversi, ma sigillata nella scia rigorosa dei testi. «Suono era e fluiva/ e il brivido dentro il ciottolo/ era vuoto a strapiombo» (Lorenzo Calogero). La poesia è quel “vuoto a strapiombo” – non pienezza di canto ma impossibilità di parola, non vaso che contiene ma brocca spaccata, che raccoglie l’acqua e la versa fuori di sé.

La scrittura poetica non è una visione da opporre al reale ma la sostanza del reale stesso. Il poeta dovrà assumere, come regola fondamentale, la ricerca dei modi e delle forme in cui tradurre il suo sogno, senza tradirlo: dando la propria forma all’ossessione che lo pervade, alla caducità a cui tenta di far fronte. A traccia di questa mancanza, di questo profondo sentimento dell’effimero, il poeta lascia delle parole. Le parole restano all’interno di poesie che, lette e rilette, diventano humus per altre poesie che saranno scritte. Si delinea una scia non destinata a sparire.
Ogni poeta, leggendo altri poeti, ha la curiosa sensazione di abitare in una comunità dove ogni abitante rappresenta il dolore della caducità terrena nella sua versione, cercando parole che vivranno oltre la sua morte, trascrivendole su fogli, schermi, muri, come in un continuo atto di “resistenza” (Gilles Deleuze). La resistenza è l’atto in cui la vita si oppone al “destino della vita”, che è quello di perire, e racconta l’insopportabile mancanza della morte con parole che non vogliono mancare ma restare eterne. Si tratta di un’eternità che non assume mai il valore del monumento egotico o della fede ultraterrena ma celebra, laicamente, lo sparire dell’uomo da questo pianeta. Una sparizione fatta di segnali che ne parleranno sempre. Un morire composto di segni che restano – uniche, sole, determinanti consolazioni. Il dolore della fine viene evocato da parole che, descrivendolo, lottano contro qualsiasi idea di fine, creando e ricreando l’illusione della presenza. «La sostanza della verità è unica: forse è la nostra necessità di esistere, la necessità di esistere in ogni cosa. Noi esistiamo in tutte le cose (Leonardo Sinisgalli)». Ma a questo esistere Samuel Beckett e Luis-René des Forêts nei loro testi oppongono la necessità di “fare silenzio”, quasi ci intimano, attraverso parole che continuamente riproducono e rappresentano l’impotenza a parlare, il silenzio.

Ogni poeta condivide lo stesso destino: circoscrivere la sua illusione di esistenza dentro uno schema di parole, opponendo alla disillusione del dissolvimento le tracce inequivocabili di quella presenza, il suo lavorare con ostinazione ossessiva questo tema. Ma, come osserva Danilo Kiš: «E tutto ciò che sopravvive al nulla è una piccola, vana vittoria sull’eternità del nulla». Il poeta, augurandosi una precaria immortalità, è sempre insoddisfatto di quello che fa, travolto dal costante lavorio sotterraneo dell’“essere” delle parole contro il “divenire” della vita che muore. Se ogni poeta cerca la sua voce, per individuarsi dal nulla, la sua voce, necessariamente, deve sottrarsi alla cifra dell’individuazione perché “tormentata dall’infinito”, come Il Bardamu celiniano del Viaggio al termine della notte.
Il progetto reale della poesia è minare, alla base, ogni edificio letterario che voglia fondare la sua esistenza su qualcosa di estraneo alle sue forme. La scrittura poetica è lontana da qualsiasi visibilità: nel momento in cui cerca di tradurre l’invisibilità in forme, non fa che aggiungere nebbia a nebbia, pur rispettando i contorni del paesaggio. È il contrario di uno schermo in cui giocare le possibilità combinatorie dell’immaginazione. È superficie opaca, increspata, isola emersa e sommersa, cratere e lava. Non aggiunge niente al mondo: vuole dislocarlo, deformarlo, deviarlo. Il poeta, scrivendo, stana prede nascoste. Si pone in agguato. Sorveglia, capta vibrazioni sonore, risonanze particolari. Aspetta che la preda lo raggiunga per afferrarla; e appena ce l’ha tra le mani, prende tempo, la osserva, prima di intuire una vaga somiglianza fra il suo occhio atterrito e il proprio occhio attento: quindi la lascia libera. È solo in quel momento che può scrivere del suo incontro con lei. La verità è nell’attimo magico della risonanza che genera l’effetto, nell’incontro fra un oggetto che sfugge e una mano che cerca di tracciarne il contorno, un orecchio che vuole riascoltarne l’eco.
Nessun poeta possiede le parole. Sono loro a possederlo. E lui è voce tra le voci, disseminata in intrecci, polifonie, mescolanze, tracce. Il poeta non può trovare la sua originalità che nelle variazioni di queste tracce, ripetendo la stessa frase come un attore che, ogni sera, intona il suo monologo con vibrazioni sempre diverse, perché l’arte è la litania della stessa intonazione.

In una parabola narrata da Borges un uomo parte per trovare un tesoro e compie un viaggio lunghissimo. Durante il viaggio incontra una persona che gli racconta un sogno dove descrive proprio il luogo da dove l’uomo è partito, il cortile della sua casa, il pozzo al centro del cortile, e gli rivela che in fondo a quel pozzo c’è un grande tesoro. L’uomo riparte, torna a casa, scava sotto il pozzo, trova il tesoro a lungo cercato, che è sempre stato lì, a due metri da lui. Ma comunque ha dovuto affrontare un viaggio lungo e faticoso per incontrare chi gli avrebbe raccontato un sogno dove era racchiusa la realtà che cercava, il tesoro da trovare – contiguo a lui, non irraggiungibile, non inenarrabile. Il poeta usa «le parole da sempre, ma come se venissero da un altro mondo» (Cees Nooteboom).
Alcune esperienze della poesia contemporanea rappresentano la volontà di inventare, con le parole dell’alfabeto, costruzioni fantasmatiche di perentoria nitidezza, dove l’oggetto poetico è la percezione verbale che l’ha pensato e determinato. Le forme grammaticali non sono più il neutro territorio di una sperimentazione linguistica ma le spie di una prospettiva del mondo che, attraverso la combinazione delle parole in quelle forme, accede a un’originalità rifondante. Il testo poetico esiste e resiste, non tanto perché ricama l’ennesima variazione sul nulla, ma in quanto individua, ai margini dell’afasia collettiva, un necessario accordo di parole.
Scrive Vicente Aleixandre: «Fare è vivere ancora, / o essere vissuti, / o prossimi. Chi muore vive e dura». Il poeta intraprende un lungo viaggio per poi tornare a sé stesso, al suo centro: che è abitare le parole vive contro il morire della vita. Le parole sono le sole tracce del suo passaggio terreno. Solo attraverso di esse, in modi lievi e diversi, può fingersi immortale. La magica sincronicità è questo contrasto insanabile, tra vita e morte, che solo le parole hanno il potere non di guarire ma di lenire. Scrivere è sentire qualcosa di più “grande” di noi, che ci ammutolisce ma di cui dobbiamo fare parola, perché il non fare parola è la morte reale, perché è il fare parola la finzione della nostra immortalità, l’azzardo contro la caducità, l’apertura al sogno. La poesia è rivelazione di parole che nasce dalle parole. Dentro quel tessuto verbale saldo e preciso vibra un alone psichico dove si addensano percezioni, epifanie, catastrofi; dove si dissolve e si riforma ogni volta il mondo e non si può mai pronunciare la parola giusta che lo definisca, quella parola che esita e si contraddice, o troppo tanto o troppo poco, viva nell’eccesso o nell’afasia. Indica Roland Barthes, nelle sue Leçons: «La letteratura […] sta dalla parte del mal dire, del troppo e del troppo poco, della lacuna o della ridondanza, del troppo presto o del troppo tardi, del doppio senso e del controtempo». La poesia, in questo non lontana dal pensiero di Barthes, si espone nel suo difetto e nella sua inadeguatezza, che per ogni poeta è cifra intraducibile della propria navigazione del mondo e nel mondo, l’accordo enarmonico tra la forma poetica e la tensione di un destino: «le sotterranee lingue dell’autunno/ fiamme dal sottosuolo / bruciano foglie e cenere / nutrono le gemme nuove» (Antonio Porta).

Fëdor Dostoevskij fa dire ad Aleksandra Ivanovna, ne L’idiota: «Una volta sola le riuscì di sognare qualcosa di originale: un monaco solo, in una stanza buia, dove lei aveva paura di entrare». Quel “monaco solo, in una stanza buia” – forse la matrice da cui partirà Anton Cechov per scrivere il suo splendido racconto Il monaco nero, lirico resoconto di un delirio –, quel “monaco solo” non è nient’altro che la notte buia da cui scaturisce, per potente utopia e petrosa resistenza, l’acuta bellezza della scrittura: il suo “grande, splendido deserto”. Quel “monaco solo, in una stanza buia” è la condizione necessaria perché la parola poetica continui a resistere, trafitta e nutrita dalla sua solitudine. Come scrive Friedrich Hölderlin: «…talvolta avrei preferito vivere in qualsiasi altro posto piuttosto che in compagnia degli esseri umani». Soltanto il poeta può vivere in quel luogo della mente (“qualsiasi altro posto”) che resta sempre eccezionale rispetto alle leggi condivise e supinamente accettate della comunità di appartenenza.
Scrive Nanni Cagnone:
«Un giovane poeta dovrebbe avere più cura del suo carattere che della sua scrittura; non dovrebbe farsi incantare dall’avvenenza del linguaggio ma confidare nella sua qualità asintotica. Un giovane poeta dovrebbe cercare nelle cose parole non sue; dovrebbe pensare nel percepire; non dovrebbe adulare il linguaggio o soccorrere il senso; dovrebbe essere incostante […] Il poeta confida di trovare un accordo con ciò che la mente ha svelato per lui: un accordo senza guarigione, “difettoso”, ma che gli lasci tenere il sentimento della cosa con sé, come nell’oscurità un barlume».
Il “sentimento della cosa” è da trattenere con sé come un barlume: non ancora parola ma presagio del suo disegno, traccia della propria vita a cui dare forma verbale: «Solo nella personalità è la vita e ogni personalità riposa su fondamenta oscure che devono essere anche il fondamento della conoscenza» (Friedrich Schelling). Di quelle fondamenta oscure il poeta è il primo e inappagato esploratore, sempre sconfitto e sempre pronto a ritentare l’avventura, proprio perché la poesia ha un rapporto complesso e tragico con la letteratura (perché non è letteratura ma scrittura) ed esiste nel momento in cui si fa cosmo modellato dalle vibrazioni altre della parola. Ha ragione Maurice Blanchot quando commenta: «Scrivere è la forza più grande perché infrange inevitabilmente la Legge, tutte le leggi, compresa la propria. Scrivere è fondamentalmente pericoloso».

Marco Ercolani (Genova, 1954), è psichiatra e scrittore. Per la narrativa ha scritto: Col favore delle tenebre, Praga, Il ritardo della caduta, Vite dettate, Lezioni di eresia, Il mese dopo l’ultimo, Carte false, Il demone accanto, Taala, Il tempo di Perseo, Discorso contro la morte, A schermo nero, Sentinella, Turno di guardia, Camera fissa, Prose buie, Preferisco sparire. Colloqui con Robert Walser 1954-1956, Destini minori, Un uomo di cattivo tono, Senza il peso della terra, Storie forse incubi, Essere e non essere. Per la saggistica: Fuoricanto, Vertigine e misura, L’opera non perfetta, Il poema ininterrotto, Fuochi complici, L’archetipo della parola, Galassie parallele. Per la poesia: Il diritto di essere opachi, Si minore, Nel fermo centro di polvere. I suoi taccuini sono raccolti in Sentinella e Nottario.
Partecipa al convegno internazionale “Bruno Schulz: il profeta sommerso”. Vince il Premio Montano, il Premio Aforisma – Torino in sintesi, il Premio Morselli e il Premio Smasher. In collaborazione con Massimo Barbaro scrive Paesaggio con viandanti, L’arte della distanza, Corrosioni. Nel 2020 ristampa Il mese dopo l’ultimo (Amazon independently published), con fotografie di Chiara Romanini e postfazione di Giorgio Galli. Con Lucetta Frisa ha fondato e diretto la rivista “Arca” e “I libri dell’Arca”.
Attualmente Marco e Lucetta sono redattori della rivista online “La foce e la sorgente” per “La dimora del tempo sospeso”. In coppia hanno scritto: Détour, L’atelier e altri racconti, Nodi del cuore, Anime strane, Sento le voci, Il muro dove volano gli uccelli, Diario doppio e Furto d’anima. Di recente pubblicazione, per le Edizioni Medusa, L’età della ferita, una riflessione sui diari di Kafka.
Siti web:
www.marcoercolani.it
https://ercolani.art.blog/