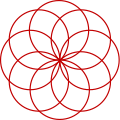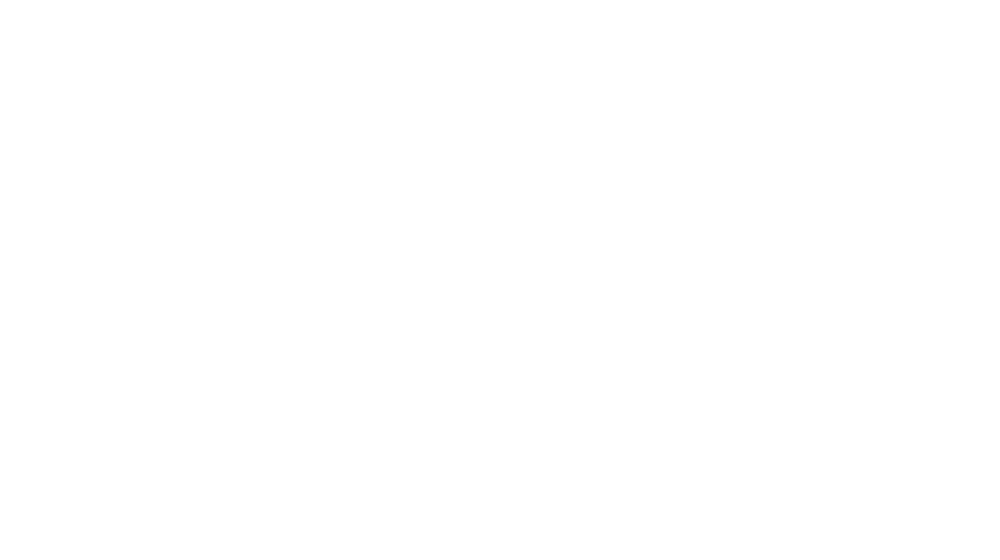«Non che tu possa di Dio / sopportare la voce, per nulla. Ma il soffio / ascolta, l’ininterrotta notizia, che da silenzio si forma». Con queste parole Rainer Maria Rilke nella prima elegia duinese restituisce al poeta, nella sacralità dell’ascolto, il compito di percepire l’«ininterrotta notizia» che emana dal creato.
Assomiglia a questo udire nudo, spoglio di ogni artificio o struttura, quello che Daìta Martinez fa dei territori umani e naturali che la circondano, nella sua magnifica Liturgia dell’acqua, edita da Anterem Edizioni per la collana Nuova Limina, e finalista alla trentaquattresima edizione del Premio Lorenzo Montano.
Martinez ci sospinge con grazia soffice, sussurrata, a un ascolto antico. Nel suo canto iridato, la materia sembra esprimersi da sé, nei propri suoni e colori. Celata ai più, si adombra alla ragione; ma è lì, nell’intuizione purissima, che si può cogliere e farne dono:
«la liturgia dell’acqua / pianissimo la bocca / quasi un senso nudo».
Questo spogliarsi di ogni architettura, questo tralasciare il sistematico costrutto, è un passo indietro arduo, malfermo, ma è il solo battesimo che permetta di esperire il vero.
L’umano è costantemente proteso, ottenebrato dal proprio istinto razionale del catalogare, strutturare, separare; del tracciare, del connettere, del distinguere; del flettere ai propri significati, del dettare divisori. Ma, mentre l’atto e il moto vorrebbero agire, lasciando continua traccia di sé sul reale – pena il perenne non comprenderlo –, esiste un paradosso che armonizza la creatura al suo paesaggio: è il passo indietro, silenzioso, sensitivo, che premia con la percezione dell’istante.

La poesia di Martinez è un suono lirico che riproduce il soffio del cosmo, sinfonia primigenia vibrata nel poeta, che si fa corda, arco, cassa di risonanza, strumento. Da qui l’universalità del canto, un monodico intonare, mai solipsista, né isolato, piuttosto un richiamo dalla cima, cui fanno eco mille suoni dalla vallata, i sospiri delle variopinte creature in ascolto, con gli occhi accesi dalla poesia.
Liturgia dell’acqua è un’opera rituale, in cui calici di testo liquido, senza segni d’interpunzione, si raccolgono in unità compatte ma fluttuanti nel loro interno, e occhieggiano da un universo di sensazione interminato e sinuoso. La poetessa, dal rumore di fondo che è l’esperienza comune della vita umana, eleva un distillato melodico, messe multisensoriale, intercalata solo da brevi pause – spazi tipografici multipli – dove sembra abitare il fiato interrotto, l’emozione che insorge, il varco dell’evasione: dal capire al sentire:
«d’aurora un oltraggio è il bucaneve / immacolato il bianchissimo seno».
Nel leggere alcuni poeti, si avverte la posa: ricerca stilistica esasperata, lessico e ritmo intarsiati come cori lignei in manierate cattedrali. Il fine emerge, e sottrae anima al testo: sorprendere o compiacere non sono atteggiamenti che trattengano il palpito, ed è esperienza comune che le parole, se addomesticate, si ribellano: dalle costruzioni artificiose, il senso fugge senza voltarsi.
Martinez, nella purezza formale, conserva la scioltezza degli appunti a margine, dei disegni tracciati senza finalità, in un contrappunto di significati che sale rapidamente in quota, fino al valico da cui tutto appare, miniato, rischiarato. Nei «segni custoditi / in un quaderno d’istinto si spolvera s’impolvera il delirio»: da questo atteggiamento da cahier – fresco, incorrotto, weiliano atteggiamento di cronaca interiore – emerge il sotteso, cioè il reale.
Le liriche di Martinez sono il germogliare di un bosco sacro, sono il caduco aggregarsi di una nube, un ricamo di spuma sul bagnasciuga: un evocare impalpabile e alato che dilegua tra le mani, che risuona nel proprio svanire. Sviluppo spontaneo, essenziale, in cui le parole sembrano chiamarsi l’una l’altra: il multiforme che interagisce e respira, e che davvero è.
In quest’opera mirabile vi è la traccia che si fa senso. Il cammino di Daìta è uno sterrato candido, che biancheggia tra ciliegi in fiore, baci d’acqua, salmi della sera; nella trenodia delle cicale, tra agrumeti e girasoli, nei sentori di arbusti bagnati di luce, nel precipizio delle rondini; e assolati crocevia, cortili di corse bambine e soffici pendii, fioriture e campi aurei, notturni di madreperla.
Liturgia dell’acqua è una sintesi magistrale di penetrazione poetica, abbozzate narrazioni, sonorità inattese: a volte morbidissime, a volte barbariche nelle crude allitterazioni; una scrittura sapiente nei ripetuti enjambements, negl’improvvisi fruscii dialettali:«e le sue labbra / ammucciate sutta sta finestra di / sciroccu / mentre accoglie di maiolica i ritorni o / i ricami di campana / spostarsi la maniglia dal / cuore perduto sull’orto a l’una corta il vicolo la / ferita una riserva di limoni quando di scheggia / si scodella rado il mare ché siamo soli premuti»,
nell’aulico che scocca garbato dal colloquiale, di un poeta che ha la naturalezza del maestro d’arco, e genera immagini nitidissime, frammenti di vita e improvvisi strappi, che feriscono, bagnano gli occhi:
«non atterrare d’ombelico / carezzami piano il cuore».
Eccola, la poesia, in questo sconcerto di avvertire l’istante, nel frammento che tralascia ogni ragionevole disciplina. Se è nel tentativo di chiusura del cerchio – la trappola della razionalità – la forzatura, il distacco dal vero, l’esilio, Martinez non fa mai l’errore di stringere la sabbia nel pugno. Si appressa anzi alle cose deboli e innocenti lasciandole palpitare, trasmigra negli universi paralleli che attorniano il piccolo, fugge alle regole del presente e dell’attuale, e ne fa viaggio magico, canone e misura, pratica claustrale:
«come odore bambino e / sulla culla t’implora un / sonno risorto dal fondo / sacro suo corpo assorto».

Il perfetto racconto dell’accadere interno ed esterno di un incontro d’amore, da evento puntuale, contingente, si disfa nell’eterno separarsi e ritrovarsi, nel sipario tra interiorità e vissuto, nel chiarissimo del concreto che, in piena luce, non è che riflesso e rimando di un ombroso contraltare, la nostra pulsante risacca interiore:
Il perfetto racconto dell’accadere interno ed esterno di un incontro d’amore, da evento puntuale, contingente, si disfa nell’eterno separarsi e ritrovarsi, nel sipario tra interiorità e vissuto, nel chiarissimo del concreto che, in piena luce, non è che riflesso e rimando di un ombroso contraltare, la nostra pulsante risacca interiore:
«trattenere l’attenzione in un petto / fermo alla stazione s’accresce la / limpida misura d’un incontro né / l’ultimo ridà loro cinte le pupille / quasi campo assolato nel grembo / proteso l’incline pigolìo del cielo».
Come ben evidenziato da Maria Grazia Calandrone, che introduce e accompagna il testo, Martinez stabilisce un patto di lealtà con il lettore, e manifesta di avere profonda stima nei suoi apparati di ricezione, decodifica, amplificazione del messaggio. Nel lasciar planare liberi i suoi versi, nessuna spiegazione, nessuna catechesi: il percepito trasmesso in modo inerme, nel solo recipiente di un’«armonia tendenziale»: questo il dono di luce, la grazia portata sul palmo, a beneficio di chi legge. E una «sintesi a priori» che è il lavoro durissimo e lieve del poeta: unificare il percepito, silenziare l’interferenza statica, arrotondare le spine della disarmonia, defibrillare il reale, farlo vibrare all’unisono, facendolo intendere con l’immediatezza dell’unico, dell’«odore di una rosa», che anche Thomas Stearns Eliot nelle sue riflessioni metafisiche tanto cercava.
Nell’opera di Daìta il passaggio dall’intensità di un vissuto puntuale alla reminiscenza improvvisa, la dialettica tra presente e passato rendono struggente il nostro abitare il tempo, mentre gli sgomenti del cuore, nel passaggio tra fisicità personale e immensità del creato, ci rendono particella luminosa in risonanza, smarrita del proprio stesso bagliore:
«la paura subito la paura / si disfa dai rivolti la luna / è bellissima».
Nella liturgia – l’etimo è noto – vi è l’operare in pubblico un rito sacro, a beneficio di molti: un servigio sacerdotale, che invoca la purezza e il rigore di un portato universale, omettendo il sé. Questo canone liturgico non poteva che essere d’acqua, per una poetessa che incarna la più tesa e lucente essenza mediterranea; le sue parole dorate, arcaiche, misteriose sembrano adunarsi negl’invasi di pietra in cui la scogliera si scava, a volte, alle pendici di un dirupo, per trattenere le sue furie di sale in conche benedette, giacimenti d’azzurro, di conforto e di luce.

Il testo si parifica nel giustificato, ma ancor di più, nell’uguale lunghezza tipografica dei versi è pacificato: si presenta a piccole, regolari masse compatte, come il celeste e riconciliato tumulto del mare, che trova la sintesi dell’immobilità molteplice, del fremente posare. Un profluvio sensorio, lustrale quintessenza d’una celebrazione corale frazionata nell’attimo, fonte tersa che colma del suo turgore gl’incavi di significato evocato.
C’è qualcosa di fatato in questo libro di Martinez, che risveglia e accende sensi sopiti, nei sentori selvatici di un Mediterraneo eterno, nelle ombre d’affanno rischiarate, negli ardori di una Sicilia acquattata, odorosa, silente, grembo di fiori e spine, scossa da brezze fragranti, annegata nel blu dei silenzi marini. Protagonista la Donna, che è cardine e sostanza, lacrima e candore, rituale e preghiera:
«fiorano fragili mani nostre i / nostri cuori più evidente sia / verità con acqua spromessa / ai confini immersa la radice / del villaggio per allora esile / grazia le girandole bambine / noi a chiocciola innamorate / noi del corpo frugate sperse / tu assenza me fronte di lato»,
nei suoi attesi amori, nei rammarichi, nelle disfatte nostalgie:
«dai riti immobili tutti i ritorni / una fioritura di niente in quel / seme la ribelle e la casa vìola / ch’io vado sola io popolata io».
Daìta è una poetessa che non teme l’innocenza:
«ancora un sorriso sulle ciglia / il dono d’uno scoiattolo la leggerezza / di una piuma tra le gambe del basilico / ché lasciarsi un po’ dimenticare dalla / paura ha soave sapore d’un sì d’amore»,
che sa trasfigurare la malinconia in tenerezza:
«s’è annidata al viso / d’una fiaba versata / la candida guancia / impara il suo cuore / tristezza melarosa»,
che sa portare il dolore tra le dita, come un petalo tenue, pervaso di grazia:
«pochi baci sul mattino e l’acqua / dei coriandoli discesi al grembo / la minima dolcezza del sogno e / poi i gomiti come rosa spina s’è / spinato è il velo solo della croce».

È nello scirocco madido di sale e di essenze, nelle piogge sul viso, tra i campi e gli ulivi all’imbrunire; è negli angeli sfiorati, nello stridore del mattino, nell’aperto cuore del melograno; è tra le barche, il mercato, i guanciali stropicciati e le nuove aurore; nella fragilità del cielo, nel sangue spezzato, nel ricordo di inquietudini bambine:
È nello scirocco madido di sale e di essenze, nelle piogge sul viso, tra i campi e gli ulivi all’imbrunire; è negli angeli sfiorati, nello stridore del mattino, nell’aperto cuore del melograno; è tra le barche, il mercato, i guanciali stropicciati e le nuove aurore; nella fragilità del cielo, nel sangue spezzato, nel ricordo di inquietudini bambine:
«d’aria // compito d’infanzia / questa stanza / quel sopra delle tegole / quel sopra non ha difeso / i cuscini / ricamati per fame / o sonno / la custodia dei muri // era stato il silenzio a conficcare l’uva / era stato il silenzio/ a scoppiare le ore»;
è nelle ore una dietro l’altra, nei giorni e nelle notti senza tempo, nel «quotidiano sottile custodirsi», «in piedi ma a piedi scalzi odorosi di rugiada» che prende vita questo scivolare esatto, questo incantesimo di parole inaspettate e perfette, che dicono il vero senza coartarlo, che si offrono come aperta sorgente, lasciando chi legge nella costante sensazione di cadere e perdersi, e insieme d’aver preso la via maestra verso il centro: l’essere qui e ora, irrimediabilmente bagnati di vita.
Isabella Bignozzi