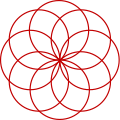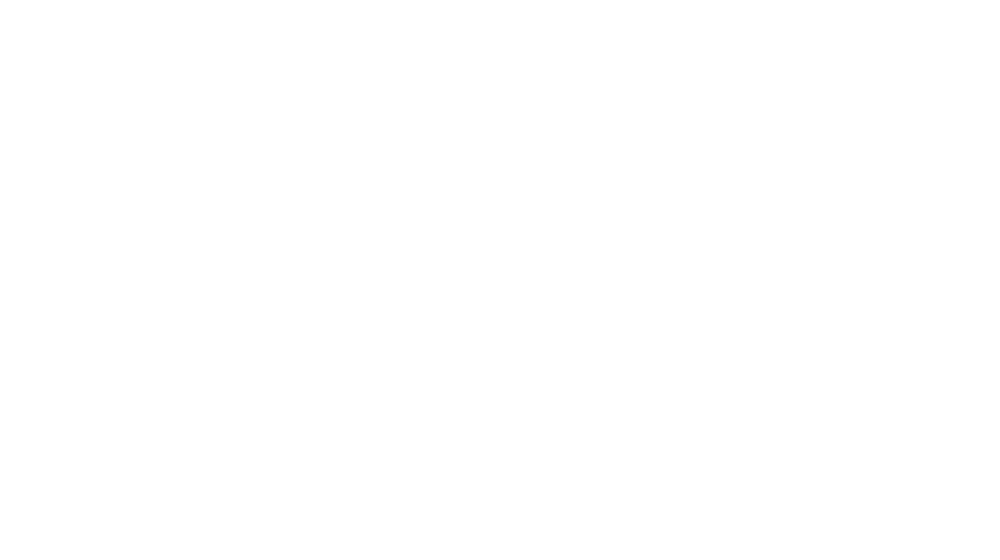Luca Sossella editore 2021
Se poesia è custodia e recapito di ciò che arde, di ciò che rifulge in tepore e barbaglio di precarietà, allora la riconsegna e deposizione sono forse gli unici gesti concessi al poeta. Di questo ci mette a parte Giorgiomaria Cornelio nella sua silloge La consegna delle braci, opera che contiene nel suo nucleo una raccolta inedita vincitrice – ex aequo con Giorgio Mancinelli, Arcana memoria dell’acqua – della sezione opera prima della XXXIII edizione del premio Lorenzo Montano; pubblicata in forma primigenia da Anterem (La promessa focaia), il volume è ora rivisto e ampliato, edito nella sua versione definitiva da Luca Sossella editore, (collana arte poetica, 2021).
Vocabolo e sintassi di Cornelio nella Consegna sono stele e fiamma, materia inscritta nella combustione, benché sopita in brace, distesa nel radiare mite del fuoco ancora acceso, che è natura trattenuta in potenza o in ripiegamento: la sola cosa che chiede d’essere consegnata.
Già in epigrafe l’intenzione si definisce nel rischioso cammino della pazienza, dell’estimo del perduto, del tralasciato; nell’impervio voto del mondare, escoriare, sino al buio della parola sgranata, alla ricerca per detrazione di quell’assoluto lucore che vive il margine, ed è prossimo a interminate oscurità.

Vi è pulsione a isolarsi, esiliarsi, nella percezione di una verità riposta che è ordito contrario a quella patente; e nell’essere consci, ognuno, di un proprio originario deviato germinare: sghembi in esistenza singola, come nell’opera comune, che si fa solerte installazione: “Noi riposiamo addormiti / dentro il calcare dei primi nomi: // erano già storti / all’imbocco, all’inguine, / e ghiacciato era anche l’alveare / della sensatezza”.
Gli umani costrutti affermano, presumono edificazione di dimora, di accorto reticolo, che sia saldo. Nel rizoma della parola che aspira a rivelare, arrestando l’immagine in immobilità docile, guastata. Ma è il consenso dell’istante, weiliano pane soprannaturale che rifugge ogni designato nome e si alimenta d’insurrezione, di intima riforma, che, nello stillare luminosa incertezza, offre lacerti di palesamento, di epifania.
Un durare nella scossa, un vibrare immoto nel ripetuto esordio, che del crollo fa scandalosa persistenza: “Scompagina dunque / il tumulo inconsutile / dei sacramentari, // capovolgi ancora / le parole appese; // di questa sommossa farai / torchio, abluzione o lavacro”.
Indicibile fedeltà al movimento, questo mancato prendere permanenza che, nel patimento del moto aperto in separazione, si rinnova in aurorale traslucenza, in nitidezza di assenza: “occorre impuntare l’eclissi / nel telaio oculare / per fissare la febbre / di questa separatezza”.

Il male della voluta spaccatura, vandalico troncare (si fa qui riferimento a Laszlo Toth, che danneggiò la Pietà di Michelangelo fratturandone la mano) è “santità all’incontrario”, in quel fluire che sfugge a ogni ermeneutico afferramento, astrusa, indecifrabile dialettica di germinazione degli opposti: “Dove avrai reciso, qualcuno odorerà un fiore, ma aspetterà a battezzarlo”.
Dal movimento subitaneo, sacrilego, una stasi più elevata della Madre violata, che non teme il bilico: con “tenue gravità in firma d’obliquo”, nella rinnovata limpidezza, si contrae in bagliore; nell’imposta mutilazione, la privazione s’arretra in levare, e si spilla a mancanza quieta.
E l’allibito figlio, umana spoglia, è residuo esausto del suo agire irrevocabile: soltanto assegnata mano, innocente esecutore di calamità, riposa ora nel suo sopore contrito, di mai afferrato senso: “Del giorno di ieri è rimasta un’umiltà di martello, ma stanca, e senza ragione di massacro […] in manicomio non conoscevano il sismografo, per misurarti il polso”.Dove si apre una cesura, che sia spacco o crepa, quello è il luogo di marcatura, convegno dovuto, nell’“albore dello strappo”, se pur ardua, impercorribile è talora la via del segno.
Se “lacrima” accende il vedere introflesso, “nube” – oscurando ciò che, immanente, preme – divarica allo smisurato; ciò che esiste in anfratto riposto, silente.
Il mandato, per certuni, è sconfessare il voto, farsi “arsione’, “acerbo dono”, e sommossa feconda che, nel demolire, diviene fondante. L’assenso: tatuarsi e marchiarsi in pena di metamorfosi, senza posa ritrovare “fondamento inaugurale / del diluvio // per sfrondare la stanchezza / del bianco sudario / del mutamento”.
“Chi rifarà l’etimo della fame?”
È tempo di ritracciare l’ulcera, la piaga, cancellando il senso esausto, “quasi come / per diserudire l’usato scrivere”. Ribattezzare la mancanza e affermarne etimologia nuova, che sia verbo e radice, tema e soffio di nuova vampa, in rincorsa di significato. Perché Homo è “Cielo e caverna”, creatura alata, impietrita in corporeità, disgiunta in segregazione, e abbandonata all’indagine di sé, con arnesi spuntati tra le dita.
Se mancherà affermazione, gli stessi sassi proclameranno (Saxa Loquuntur, Luca 19, 40); e di certe aspersioni di verità, umori di percezione fonda, che sorgono – come la sapienza della nebbia – da paesaggi e simboli, “si parla, / quando lo sapremmo / invece dettato dal tuono”.
Cornelio dice nei versi d’aver avuto in sorte faticose carte, e scaffali di biblioteche, una via di conoscenza che ha fatto da aratro alla terra d’infanzia, creta madida di “stimmate oblunghe e pensose che / sapranno forse rivoltarsi in sabbia”.
Se il monaco è tenuto al voto di “rapprendere la / teologia che non si è fatta ancora evidenza”, rimane a menda che il definito e circostanziato è in esodo costante dal centro del vero, dove che esso sia.
E dunque, se l’osservanza è richiesta, e la teoria edifica, la lealtà nel singolo cuore digrada: “Ora, scendendo l’ulcera di come / siamo fatti – qui è sempre inverno –, l’acre non declina”: per certuni avvicinarsi al nucleo di sé riconduce il giorno all’opera franca, ma segrega.

Deragliare e distogliere, rimanere nell’ortodossia della parola al cielo, nel salmo consueto, sapendosi inauditi, e ugualmente inatteso è il balsamo che fa, del nero residuo, bollore di cosa bianca.
È nel refuso, che ognuno tratteggia e ritrae, che ogni anima incarna, che si origina la semenza e il risveglio, l’effrazione al canone, motore di scasso a più infinite ampiezze. Le scritture delineano la via ma, nella stasi, rinnegano il tremore del divampare, e dunque va ribadita un’erranza senza margine, senza finitura.
E la scrittura ora, che nasce come inadempienza al mandato, armandosi di ciò che è interminabilmente migrato altrove: “ma nome è ciò che agro dalla / saliva/ è venuto a mancare. // Così s’intende la scrittura: un / lento stornare la necessità / della risposta”.
Farsi valico irrevocabile è l’ampio gesto di parziale espiazione: “Del debito, procedere col demolire la porta per la quale si passa // (a costo – chiedi – di non poter più rientrare?)”.
Perché tentare il ritorno, far sentiero miliare, innalzare segni di pietra è impudenza illusoria, che allarga lo iato tra il pensare e l’oggetto cui esso anela. Nell’esodo da sé stessi abita la permanenza, l’ala bianca che s’apre dal nero “Saremo altro. / Specie lussata, specie vagante. / L’imbianco nel corvo”.
Toccante, tra i moltissimi riferimenti culturali raffinati, tra i cenni velati il riferimento a Les trois écologies di Felix Guattari, dove ogni macchina fa a un tempo da elemento generato e generante: cosmogonia riparatrice, nutrita della fatica umana e del suo cammino mutante in creazione, e pure embrione che si dà alla luce delineando nuovi profili di realtà; il congegno, esplorando con la propria esistenza l’ontologia dell’uomo e il suo divenire, ne è prodotto e avamposto, profezia. Sibilla a cremagliera di questo stare tra le cose, nel materialismo che allontana da ogni rivelazione: “ma chi vuole la mano / soltanto per l’aratro / nega il racconto del credere”.
Sopiti nella mestizia, abitiamo la volgarità dell’incredulo (Cristina Campo), inetti a discernere “nel cero” “il buio innesto della luce”, a praticare il “pensamento sovrastante l’argilla”.
Dunque non svolare sul tangibile, ma aver cura del vuoto, del gesto supremo di “veder senza figura”: lasciare la presa sulla parola, in modo che il dire abbia la sua ombra, ciglio che, in oscurità, arde: “Dispersione è il solo / giuramento del poeta: / curarsi di obumbrare le parole. // Ecco la nostra pyrosophia”.
Se l’intento è al meno, se la via è nel destituirsi, allora lo sguardo d’allievo è rivolto all’animale, che sa il deporsi in riduzione: “Origliate sui margini l’ufficio / delle bestie quando vanno / a morire: concimano il ritrarsi; / fanno tronca, pure, la tomba”.
Così apprendere la cura, l’impresa senza profitto: continuare a lasciare “un tesoro di piccoli rami sopra delle ceneri oramai spente” come quella creatura speciale “che vive oltre il recinto dell’utile, là dove ogni cosa coincide soltanto con la parte che trabocca”.
L’essere non inclusi, o forse coltivare vecchiezza come spola nell’arcolaio delle ere, è viatico “per stanare / la triplice / crosta del mondo: / numero, peso, misura”. Liberare la realtà dai nostri parziali intendimenti. E offrire tributo e sostegno al minore, al bemolle, convolare al desolato, farsene adepti, ostendere la propria silente deflagrazione come un vessillo a chi nega l’accordo, mimando sventatezza, o assenza: “Ci alloggiano i / mezzi-dormienti. I né e né. / Fanno smorfia di / sonno perché hai addosso / burrasca”.
Si elegge, ma anche si è eletti, a vestire il presagio, a frequentare il quieto allarme, ad approntare l’astensione: “Disponete / gli osservanti scelti / all’incastro col cielo. // Disobbedienza sarà: “zabaione / scroccafuso, nocepesca, torroncino’ // (ovverossia) // preparare in anticipo / la colazione che salteremo”.

Elezione all’oscurarsi in parola sulla riva, a farsi tersi al rivelato, docili al fuoco del simbolo, come riflesso-specchio del bagliore oltre. Scriveva al poeta la filosofa Rubina Giorgi: “Forse vi sono umani che potrebbero dirsi umani simbolici più di altri, e la cui vita getta-insieme nel fuoco vivente che la nutre immagini e figure germinali o in origine lontane tra loro e ne trae creazioni nuove, anche solo qualità nuove, tempi e spazi diversi, vie di conoscenza […] gli ‘umani simbolici’ sono quelli che infrangono di più i confini dell’orizzonte umano, che amano cercare oltre questo orizzonte, che esercitano l’abbandono (la Gelassenheit di Böhme) in vista di quest’oltre, che potrebbe anche essere un Amore disumano e transumano […] L’infrangimento dei sigilli è il lavoro del Symbolon, un dio che compone insieme cose di un ardire inaudito: un dio delle nascite – che dà origine alle seconde nascite. […] La generazione della Vita, dice il Mirifico con insistenza, è ‘una lotta e un lavoro permanente’”.
Tali creature, verrebbe da dire, vivono sulla sponda, in quanto hanno essenza protesa all’ulteriore: qui “l’entrare nella poesia” di Cornelio, che destruttura ed erige nuovamente, in un impegno di immateriale creazione, che è mai esausta dialettica tra emostasi e flusso, tra sutura e lacerazione, in cui il lemma si compie e disgrega, poi di nuovo preme e coagula, scioglie e riannoda, e porge nell’ardere che prelude alla cenere, dunque è brace. Verbo labile, precario, che indica nell’indefinito, perché nulla che sia onfalico è circoscrivibile, né esiste materia fondante che sia evocabile nella precisione, oltre le declinate desinenze dell’istante.
Ferita aperta la poesia, escoriazione sul “tegumento delle rocce”, intenzionale cruentare l’organo, la vista, il linguaggio, nel pallido auspicio che si possa fare rasura profonda, fino a quello strato abraso e gemente, vivo di capillarità, pronto a dichiararsi ancora in rigenerazione.
Isabella Bignozzi