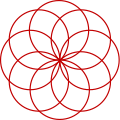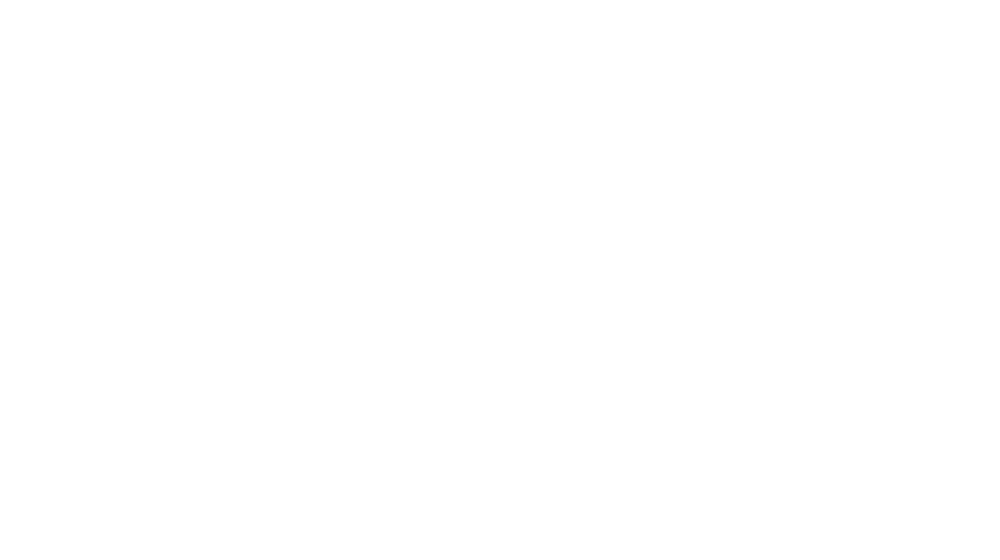Book Editore, «scritture extra ordinarie», marzo 2022
È un viaggio ancipite sulla linea del tempo, impalpabile in orma e dissolvenza, ma espresso nel più accurato dettaglio sensoriale quello che Ranieri Teti ci dona nella sua raccolta di prose artistiche La vita Impressa (Book Editore, marzo 2022).
Il poeta medita e ricorda, enumera percezioni fattesi notazioni di un taccuino dell’anima che vede le proprie pagine piene di «ombre di lettere», annunci labili, che si stagliano «nel momento dell’oscurarsi, in risonanza dicendo senza parlare».

La cosa prende forma nelle sezioni dedicate, tra luoghi, parole, movimenti dell’invisibile, nell’evanescenza degli incontri, nell’insistere dei cuori inarresi, tra paesaggi, frontiere, immergendosi nel sogno che è origine, nelle ombre sotterranee che sono notizia, se pur indecifrabile: «punto sottratto a un finale», come un durare cedevole dentro un itinerario, eleggere la frana a dimora di evidenza.
Questo «naturale cammino nella fugacità, nel terreno fragile del continuo esordio» è la condizione umana costitutiva, ancor più per il poeta, che in ostinata ricerca convoca il «disertato, lo scarto fra l’incontro e la perdita conosciuta in estuario», il mancato alla vita, l’incompreso che ci accompagna e ritorna, avendo per noi cura e ostinazione, divenendo il tralasciato che a valle depone il suo frutto.
Così, in un fermo immagine seppiato, malinconico dell’istante commosso appeso al tempo, «illesi in un saluto e con la stessa inclinazione delle braccia», viviamo nell’incontro che nasce già mutilato, nella vicinanza gracile, con il perduto che si chiama ricordo, soffocati da un precipitare in materia che è in «troppa terra, in tanto fango tramandato».
Nell’interminata via, si diviene avvezzi alle «finzioni di approdo», ci si cesella nell’incompiuto fine, si evince che «tutte le sabbie che sono in prossimità del mare non sono deserti, lungo ogni margine, quando si allungano ombre a cercare il meridiano dell’oscuro, nella membrana semiaperta semichiusa della sera»: nel perenne itinerario, tra rive e greti, in siti liminari, la tensione è a cercare alloggio e rifugio, «in ogni frammento riparando, in ogni punta».
Un’insonnia simbolica, uno smarrimento, un essere isolati in percezione per lontananza, perché l’oscillazione del sentire conosce intensità straniere al mondo. E, sullo sfondo, un reale sincopato che smargina, eppure imprime sé stesso svanendo.
Perché, nelle righe di Teti, elemento naturale e spirituale hanno pari corporeità, e sorgono da un dove di mescolanza alchemica «parole che sono paesaggi, luoghi pieni di presagi». Il punto di osservazione del poeta è una piega di trasparenza, in cui, con accesa remissività, si lascia che la vita si protragga in vibrazione e scrittura. È così che la realtà, non forzata, si mostra in bagliore, se pur flebilmente, in simultanea comparsa e cessazione, nella teoria di immagini che è rivelazione e dipartita di ogni cosa.
Nel fluire vi è l’insidia, il limo, il residuo; nondimeno nel tragitto, eletto a frana e crocevia di parola, trova spazio l’attimo lucente, sostanza alata «che dice l’adesso e insieme l’oltre», e di nuovo s’inabissa, si ritrae in negazione, e «digrigna in silenzio, non avendo luogo né soglia».

Metamorfosi senza memoria distendono il passo in territori dall’incedere lento, un rizomatico, vegetale propagarsi, un nativo radicarsi in volo, all’umanità negati per celerità e dissipazione, per oscurata moltitudine di strade, per anisotropa struttura d’intelletto, che mai collima né conosce: «La parola viaggio è un cartello che segnala uno sfarinarsi di strade, note di lontananze, ombre lente tra l’indomani e orizzonti, che mutano immemori, ossatura di terre incognite».
E ancora: «Sulla linea che unisce cielo e terra anche la geografia è destino, imprimatur del caso, nelle scene minate di un paesaggio che non grida a molto più di un ferimento, a molto più di un’ustione, che si innocua a vacuità».
A ogni fronte rimane arcano che cosa sia scritto in tali geografie che si delimitano in fusione, che si mappano nel patito, che esistono in ferita così dispiegandosi vaste, inermi a ciò che in esse s’impose. Contrade spaziali e temporali minate da un dolore ctonio, sopito ordigno di cui residua un corpo stremato, sotterraneo: «Nella schiera di quanto fu celato, violato e dimenticato, nella stagione che viene meno con le facce dei vinti, la stessa che contiene facce e catture, la stessa dei contagi, di tutte le parti sofferenti».
Sulla madre terra, la vanità delle frontiere: umane installazioni divisorie, che gridano l’inessenziale, il contingente, sovrapponendosi a una natura silenziosa e paziente, mitemente avvolta nel velo del segreto.
Il flusso di percezione continua che è proprio dell’esistere nel mondo in Teti non sembra farsi assedio ma corrente, sospinto cammino, in quell’assenso pacato che l’anima duttile e feconda accorda al reale in
aperta consapevolezza, in flessibilità. Sapendo che non nel messaggio compiuto, non nel sensato evento, ma nel minuto ritaglio, nel disavanzo s’annida l’avviso, l’impenetrabile fulgore dell’attesa notizia.
Mai definitivo l’approdo, chiamato «l’inarreso a proseguire dopo la controra, dentro una notte senza custodia», in una processione di passanti che sono «confuse facce del dado, un solo miscellaneo vólto […] mentre il rimasto è solo cenere intorno alle ore»: è un divario l’istante, memoria d’ultimo passo, portato in interminato sentiero.
Un uso sapiente di etimi e lemmi, cadenze piene di ellittiche armonie, figure ossimoriche d’inconsueta dolcezza: la «moviola di domani», la «mano stretta a una separazione»; geografie sovvertite con lieve mano, «nuvole nei fondali», «lame d’erba, nella densità dell’aria»; una natura che persiste, salvifica, in soffio di risacca, nel «moto delle sabbie», nel «ritmo di riva che sale da un pianissimo»; tutto cantato in un «crescendo sospeso» che non fa uso di perentorie cesure (nessun punto fermo, nessuna maiuscola di avvio nel testo), ma solo flusso, e incanto.

Ma il lavoro di Teti è molto di più. Il poeta si discioglie in opera, facendosi emulsione di cristalli fotosensibili, in sintesi cromatica mai conclusa, si lascia imprimere come pellicola dal profluvio materico e spirituale che è la vita, il misterioso passaggio. Compito arduo, mai concluso, restituire in parola la fluida ustione di questo esistere, il cui fiore è spasimo e mandato, chiamata testimonianza.
In un’«imminenza che schianta», priva di reale fondatezza, lo spirito è prono a un «sentire ulteriore» che danna e salva, perché non abbandona «i passi sospesi» che si pongono accanto, né le «onde che si allungano nelle vertebre». Ed è con questa postura che l’anima poetica non ammutolisce di fronte al «gelo dei significati», ma ha cura del «senso caldissimo» che gli è donato, di un esserci sempre rinato a sé, che percepisce il piccolo, «echi di mitosi e battiti, ritmi di foglie e palpebre», e raccoglie ciò che cade, «quello che la vita depone e lascia all’incanto».
Teti ci fa un dono grande, nel «lascito finale» che illumina «alla fine di un libro un istmo, a un passo dalla fine l’apertura, nel gioco del rovescio»: nel continuo percepire e ferirsi, il poeta è pago del quotidiano, visitato da «un lento addosso» cadenzato in passi sul selciato; tra assedi e rifugi, il segreto è lasciarsi aperti, addestrarsi a un’altezza che si faccia visuale e risonanza; non negarsi mai agli orizzonti, essere insieme luogo e visione, e rendersi pergamena, diario, di ogni cenno che sorga.