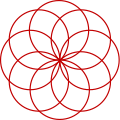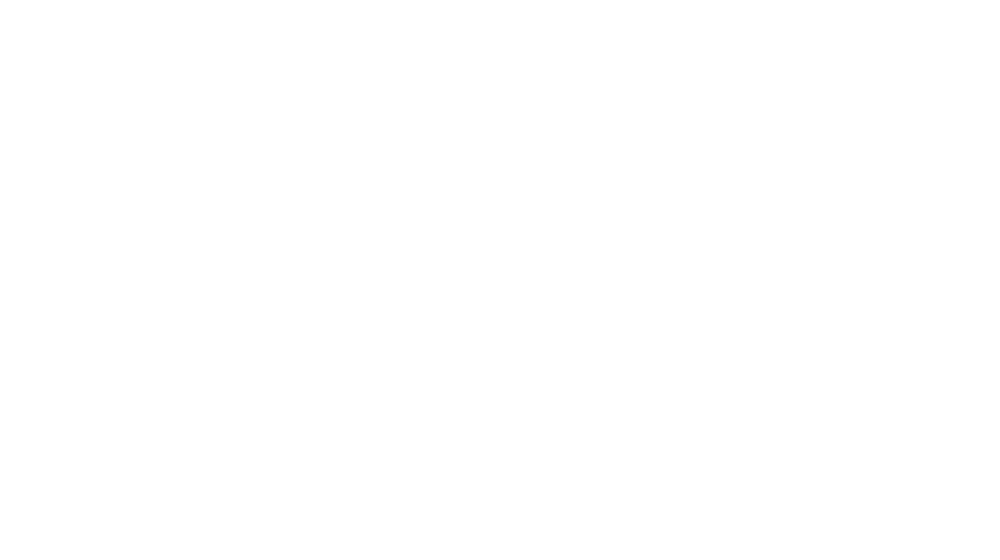MC Edizioni, collana Gli insetti, a cura di Pasquale Di Palmo
“Per quanto si bagni la mano nell’oscuro, / la mano non si annerisce mai. La sua mano / è impermeabile alla notte” diceva Ghiannis Ritsos del poeta (in Molto tardi nella notte, traduzione di Nicola Crocetti, Crocetti Editore 2020), ed è così, a ben guardare, nell’intera opera di Stefano Massari, e in particolare nell’ultima sua silloge Macchine del diluvio (MC Edizioni, collana Gli insetti, a cura di Pasquale Di Palmo). C’è un pregresso buio, e un’ipotesi sempre allertata, sempre precipite nella poesia delle Macchine: fin dalle epigrafi in apertura, la morte delimita in ombra ogni bellezza, ed è sovrana del tempo.
Divinità nera, soffusa nei giorni, incede senza margine verso i nostri corpi, fiutandoli. L’unico sostegno rimasto alle vertebre è la rabbia, pietra d’angolo del resistere, in un vivere commutato, espropriato, in cui ogni individuo è trafitto da un destino cristico senza redenzione. Il dolore è muro di epilogo, esito sordo, e la soffice resa rimane un fasto non percorribile: “con gli occhi abituati al buio / e le finestre sbarrate per paura dei topi / dei servi e del caldo // [con le unghie masticate fino all’alba / e tutto il nervo del secolo addosso] // io non ho più fede in niente / ma non posso“.

Massari enumera dodici morti – numero apostolico – affrontandole in piedi: con parole crude ne rovescia la pelle, nel tentativo di farne vuoti involucri, ma in ognuna c’è qualcosa di ripetuto, di eternamente presente, di non esorcizzabile: «sei volte annunciata arrivò la morte / dell’amico più grande / che diceva ormai / di neanche pregarla che non c’era bisogno / perché la pelle era già vetro […] non avrebbe lottato / ma pianto / all’infinito e dormito con i topi nel letto / che per rispetto gli avrebbero mangiato / soltanto una mano la madreperla mano»: ecco Patroclo, ecco l’amico fragile, e lo spezzato candore che, di fronte allo scempio, irradia tutta la sua luce ultima. Bellezza di cristallo, sua ombra la morte, nell’amore intrinseca la perdita; e, nel restare, il distratto abbaglio che esige il tributo del buio.
Nell’universo che boccheggia in questo male, l’aurora è allarme, e spettrali «figure del diluvio» muovono in un presente deforme, dove le persone sono davvero maschere intimate al viso, nell’obbligo di esprimersi in ruolo predefinito: il migrato, il vincitore, il lieto esecutore, i resistenti, l’innamorata, la bambina che piove senza pace.
Nel teatro dei vivi, se gli umani sono ridotti ad archetipali figuranti, anche i dispositivi di realtà agiscono al diluvio, sono educati al disastro, e vengono evocati dal poeta come piaghe, bibliche lamentazioni: riportati con icastica dovizia, senza artificio retorico, nel profluvio, nel tepore del sangue: «i succhi bassi dei cieli uguali che dimenticano / il movimento di tornare l’unione di fiorire / gli uccelli fissi idioti sui campanili santi e vuoti», e ancora: «la rotazione delle torri le nervature locuste / cresciute unanimi e insonni le cuciture dei cementi / e degli allarmi le giuste confessioni delle carni».
Annotazioni di sofferta presenza, di estraneità che vive l’esilio, il ripudio.
Fino a un diario. Denominato «nostro».
Chiave di volta, il processo di riappropriazione e riconoscimento di un reale che, se pur frammentario e dolente, non è più straniero, non rinnegato e disconosciuto, ma traccia di vita. Imperfetto sì, anche questo nuovo calendario, gremito di ustione, ma altresì vestibolo d’alba «perfetta e finale»: parole queste dell’alba stessa, ora persona vera, libera da etimologie, da maschere, ora compagna, luce: «arcobaleno improvviso come un ringhio /come una legge». Nel patto di tentata fede «una parte di guerra e una di azzurro / e l’altra di sabbia da masticare piano»: chiara la via, se «i fiori resteranno incompresi /ma saranno nostri», se vi sono «scritti uguali sulle linee / delle mani».

«L’ho riconosciuto il male quando ti scende / dalla fronte appoggiata alla mia uguale / la paura quando ti cade ininterrotta tra le dita / e mi attiri nel pieno del tuo freddo che dici / freddo con voce di bambina».
Non è dato alcun lieto fine statico, ma piuttosto un equilibrio, che muta il fango in volo in ogni istante, e di cui va cercata l’alchimia, ripercorsa: «impareremo questo coraggio / di obbedirci di curarci / di non dividerci mai più».
Non è la notte il luogo del vivere, sembra dire il poeta, né la supposizione di un intatto giorno risolto, pacificato nella luce. È sul margine teso del reiterato esordio, sul nuovo in bilico, sempre temprato in allarme, che il cuore funambolo di Massari dispone il tempo alla vita: abitare l’aurora, quel riaversi dell’oscuro portandolo in bocca, quell’annunciarsi dell’ignoto che piegherà all’incompiuto, che piegherà talora allo splendore, ma in ogni caso tradirà. Eccolo, il punto geometrico della grazia, il senso purissimo dell’amore: nello scenario che ogni sognato abiura e disattende, aver cura della cura, lasciarsi frustare il viso dal male del mondo con ostinata innocenza, spezzando in due il pane delle ossa, il cuore della carne.