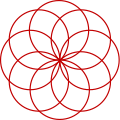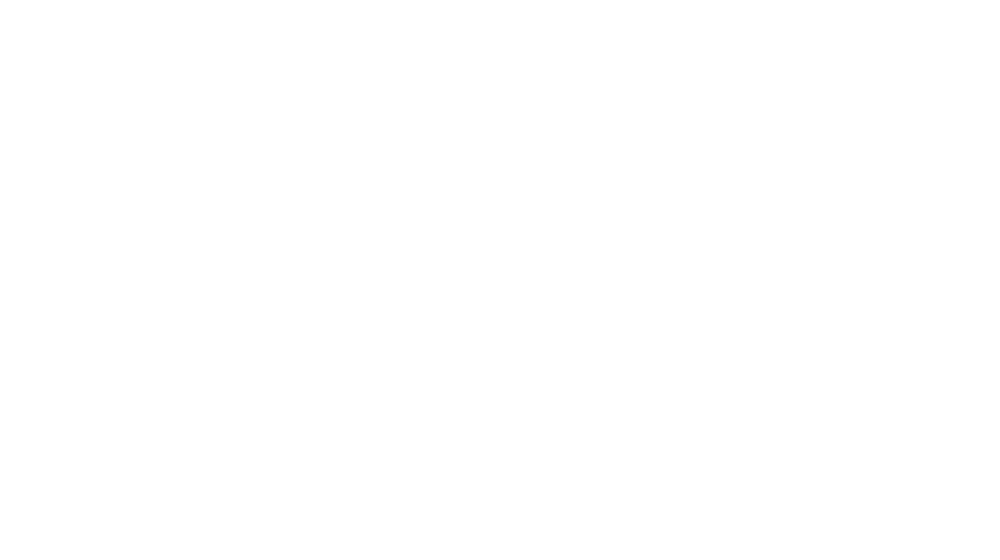Les Flâneurs Edizioni
Collana Icone, diretta da Alessandro Cannavale e Elisabetta Destasio Vettori
Prefazione di Luigia Sorrentino, Nota di Alessandra Bava, postfazione di Mattia Tarantino
Dalla prefazione:
Scisma, il diario che Ilaria scrive giorno per giorno dopo il risveglio dal coma, è, in realtà, una fuga dalla morte e la possibilità di una nuova vita. L’opera in versi è la testimonianza di un’enorme sofferenza fisica e psichica di chi è in un altrimenti, in un luogo nel quale all’esperienza soggettiva e umana si intreccia il tema della trascendenza intesa qui come ciò che si trova al di là, l’altro volto, il limite che ci interroga continuamente.
Luigia Sorrentino
*
Dalla postfazione:
Appunti per un corpo da sfatare, oppure un Risveglio. Tecnologia della luce, di gestione della morte, appunti per decifrare i segni, dirottare il presagio.
I Risvegliati, il popolo dell’oltremondo, chi-ha-avuto-accesso. I Risvegliati, ma come uno scherzo, gli innocenti. La voce, all’improvviso.
Mattia Tarantino

*
Ci sono creature per cui l’esserci in materia non è placida stasi, ma continuo dissidio tra opposti: il senso della propria concitata corporeità confuta anelate, impercorribili limpidezze. Può accadere allora che la tensione all’angelico, che nell’umano dà di sé solo barbagli, chiami all’infero con sublime impostura. E se angelico è il volo, pieno e fulgido, nell’immaginario corrente, e ascendente, verso l’alto e l’aperto, verso la casa della luce; ebbene esiste un volo cavo, che “forze cieche” persuadono come assolvimento definitivo, come attuazione inderogabile e fatale di sé: togliersi via dall’ovattata crisalide, dall’opacità della carne, verso una trasparenza che sia diafana integrità, estenuata in purezza: “Queste mie lacrime / siano poi scambiate / con il corallo puro / e trasformate in / essenze marine. / Questo mio dolore / sia poi germoglio / di mille giardini fioriti”.
Il peso emotivo dell’esistenza, nelle anime che sentono tale continua tensione al commiato come l’esattezza di una designata alba, come bramata unione attraverso la disgregazione, diviene talvolta un giogo intollerabile: “gravitare nell’aria imbastire una libertà. / Dissipa il filo che tiene insieme / l’io e il noi”.
Essere individuati in un corpo è un esilio dall’essere; l’isolamento esistenziale, dovuto ai contorni della propria presenza, una soglia visitata da voci malfide: “La voglia di andare dove nessuno può ti spinge tra le braccia dei fantasmi. // Cerchi l’unico oltre la scissione, nessun abbaglio”.
La ferita del margine può indurre a cercare l’infinito “fuori dalla pelle”: ma non tutti sono accolti nell’oltre, il destino di alcuni è essere ricacciati nella macchina, come una particella straziata, che porta le stimmate del tentato volo: “Madre di voci conosci il male. / Catturata dal tempo sopravvivi”. Residua la spoglia di un attraversamento, che ha la nettezza livida di un corpo-nel-dolore, ancor più di prima albatro che annaspa sulla tolda: la creatura orfana, coatta al ritorno, è ora esponenzialmente smarrita: crudele è la riconsegna a quell’automazione che, in apparenza acefala, avanza triturando le nostre sorti: “Forze cieche si sono servite di me / per consumarmi, restituirmi indifesa. / Devo ricominciare da zero. / Imparare tutto daccapo, / restare sempre indietro / mentre vi guardo voltarvi”.
“Un universo abitato da relitti, ombre, profonda inquietudine” scrive Alessandra Bava nella nota con cui accompagna il volume, riguardo il “muoverci tra ciò che resta, tra la distruzione e lo sfacelo, ma anche […] verso un’altra aurora”.
Perché, accanto a ciò che è perduto, vi è un serio dono: l’investitura alla testimonianza, il senso severo dell’esistenza come cronaca di rimpatrio: cui Ilaria ottempera con una scrittura feroce di esattezza, un resoconto dislocato da sé, temperato nell’inesorabilità: “Si schiude la ferita, sangue e buio / giacere sgraziata all’esistenza, / crebbe in te la ferita, restò nuda, / avrebbe martellato l’osso sacro, / avrei guardato tutto l’angelico / suppurare in infero, smarginare”. Quella veglia mitemente passiva, quella franta presenza che porta il peso del ragguaglio arreso, come in Maurice Blanchot: attraverso un codice sincopato, frammentato, che incarna in sé la catastrofe come cifra costitutiva dell’esistenza.
Esistere: un ostinato itinerario, arduo e malfermo, che i cieli tempestano di nomi e destini. E, come sorte, la croce del restare. “Accogliere quale deformità?” si chiede Ilaria di fronte ai danni fisici che dovrà portare. Essere lasciati soli, di fronte agli sfregi dei giorni. “Volevo essere presa in custodia”: toccante affermazione, intima chiave del libro. Perché il paradosso sta qui: andarsene dalle serre del dolore, per un luogo dove davvero si è accuditi, accompagnati, tolti dell’involucro di una singolarità insostenibile: andarsene da questo stabulario, dove l’identità è un miraggio, l’amore un tranello, l’amara solitudine una realtà primaria.
Se il corpo, unico mezzo per toccare il mondo, è in realtà un isolato involucro, ebbene la coscienza, che dovrebbe porci al sicuro e darci i mezzi per condurre noi stessi, in Scisma pare abdicare di fronte alla “ghiera del persecutore interno”, il multiplo, la meccanizzata legione venuta per perderci: “qui si aprono i multipli”, “sono tutti qui. Aspettano”.
Portare il corpo al suo limite, alla soglia di non-esistenza, all’istante della distruzione come ipotesi di barlume è l’azzardo della fiamma, che annienta brillando, atto scandaloso che strema l’ultima possibilità.
“L’incavarsi del corpo nella curva impossibile”, fare “Volo cavo” di una “nuda materia plasmabile”: liberare l’angelico dall’infero per implacabile demolizione, tentare di ridarsi essenza con annientamento, togliersi l’oppressione della forma per liberarsi dal giogo dell’ombra.
Miraggio che seduce, questo disfare il corpo col suo impudico ingombro attraverso la cruna d’ago del dolore: disgregare, sublimare: eseguire la purezza su di sé.
Il ritorno è questo atroce ricominciare, in una realtà senza “rifugio”, con “parole prime”, in cui vivere è costante “sottrazione”.
Dopo il fallimento della sparizione, l’innocenza è un cammino lunghissimo, spinato di chiodi, attribuite colpe, abbandoni, un muoversi incompreso risalendo il male della materia, facendosene carico, portandone la croce: “Le ossa sporgono dappertutto / si piaga il ventre, / e io, sola in mezzo agli altri, / festeggio la pura imperfezione. / II peso del corpo strabocca”.
Nel corpo “dissolto, dolente, arreso” imparare ogni cosa di nuovo, avere un altro nome: la nascita è una morte al contrario, nel passaggio ciò che si perde è la materia del danno su cui costruirsi.
“Tutto questo morire tornerà, dovrai poi dirgli: Non voglio più, resto qui, nelle frane. Resto”.
Nulla è definitivo, né scontato. Ogni salvezza va salmodiata quotidianamente, stando nell’umiltà della frattura, dello scisma: monito d’imperfezione e precarietà, in cui ogni buon esito è nel bilico della tensione dialettica con la possibilità del suo opposto: “Ho paura del confine interno, del perdersi, del darsi un tempo per guarire. Ho paura degli occhi alle pareti, dell’immagine, di questi corpi fantasma”.
Il senso centrifugo e disgregante rimane, ma diviene una raggiera di energie che sgomenta ma non guida il pensiero, che scuote ma non agisce il corpo: piuttosto lo conserva, nel quotidiano dolore, edotto, accurato, desto.
“Il corpo non è più tuo. È un coro”: la verità che Ilaria ci consegna è talmente centrata e ulteriore da dare vertigine a chi non sia pronto a sostenerne la potenza. Ma avere il buio attraversato alle spalle dona la facoltà di salvarsi e di salvare. Un compito durissimo, dato solo ai restituiti: “Tutti hanno un occhio sulla schiena, per guarire devi tenerlo chiuso”.

*
Da Scisma (Les Flâneurs 2024):
Giorno 1
Non immaginavo di aprire gli occhi
la voce disse: Ingoia la fame.
E poi la finestra, i vetri,
di schiena, rovescia i palazzi.
Mi sveglio nella foschia del dolore,
Quale parte di me è rimasta?
Siamo nell’aldilà?, chiedo.
No, siamo molto aldiquà, dice.
Cosa mi aspetta?
Nessuno sa se supererai la notte.
*
Giorno 31
Fino a dove riprenderai le ossa? Smembrata, senza corrispondenze. Guarda la finestra che dà sui tramonti – non puoi alzarti – guarda l’infinitezza fatta a pezzi. Sbrindella il cremisi nell’azzurro irato. L’esperienza del trapasso serva da monito, non si sceglie la morte, ci sceglie. La scrittura raggela. Guarda le ombre sul soffitto, guarda i cieli i cori rubino, guarda il cadere, la caduta, il marmo. Guarda i volti ricomposti degli altri, guarda i loro occhi. Chiedi perdono.

*
Giorno 42
Io non vedrò più luce,
voglio essere amata
dalla tenebra nerissima,
volto nel deserto.
Amata, oltre la
profezia, verso
il limite accecante
del buio
dal folle sole calante.

*
Giorno 44
Il vento entra nell’alba
si accavalla tra le gambe
lambisce ossa sfregiate
argina il fuoco, sedimenta.
Nacque nel solco del pallido
sole, nel districare nodi,
tremolante inonda ogni
mancanza, asseconda
il gemito e non resta.
*
Giorno 51
Infine resta solo
l’amore, o il bisogno
di provarlo, la vita
o il ricordo di aver vissuto.

*
Giorno 58
Molti li chiamammo fratelli
e furono armati a fuoco
e molti li chiamammo amanti
e furono rivali.
La solitudine nei muri,
le orchidee.
Come s’infrange
il fuggitivo nella
planimetria del genio.
Forse sono capace
di amare soltanto
i morenti, le stelle
di nessuno inarcate
a precipizio verso il mare.
*
Giorno 64
Fino a che punto sei disposto a scendere,
dentro quale cielo. La scelta ha un prezzo.
È rimasto l’ardore immacolato, la vita ipotetica.
Al culmine del grido l’attesa del tempo,
non dartene più.
Sai che il marmo si spacca sempre
al rovescio,
e la notte ha il suono di una lacrima.

*
Giorno 72
Non si torna indietro
dalla visione.
Verticale è solo una
prospettiva. Una forma
dell’inviolata sostanza.
Guardami, non ho più
nulla di umano. Resta,
ho paura del buio.

*
Giorno 79
Sia questo mese scrigno
di silenzi. Lo sguardo
cieco, in risonanze
celesti. Non sapremo
perché fummo scartati.
Sapremo solo la condanna
di noi stessi.
*
Centottantesimo giorno
Questo dovrebbe portarci alla resa
il silenzio delle basiliche, lo spazio
aperto dei chiostri. Solo questa
prima luce dovrebbe incidersi
nella volontà e disincarnarla.
Non la legge di un insieme
senza verità. Solo questo
giardino capace di fiorire
nel dimenticarsi.
*

Ilaria Palomba, scrittrice, poetessa, studiosa di filosofia, ha pubblicato i romanzi: Fatti male (Gaffi; tradotto in tedesco per Aufbau-Verlag), Homo homini virus (Meridiano Zero; Premio Carver 2015), Una volta l’estate (Meridiano Zero), Disturbi di luminosità (Gaffi), Brama (Perrone), Vuoto (Les Flâneurs; presentato al premio Strega 2023 e vincitore del premio Oscar del Libro 2023); le sillogi: Mancanza (Augh!), Deserto (premio Profumi di poesia 2018), Città metafisiche (Ensemble), Microcosmi (Ensemble, premio Semeria casinò di Sanremo 2021; premio Virginia Woolf al premio Nabokov 2022); il saggio: Io Sono un’opera d’arte, viaggio nel mondo della performance art (Dal Sud). Ha scritto per «La Gazzetta del Mezzogiorno», «Minima et Moralia», «Pangea», «Il Foglio», «Succedeoggi». Ha fondato il blog letterario «Suite italiana»; collabora con le riviste «La Fionda», «Le città delle donne», «Inverso», «Versolibero».